L’altra faccia del sogno americano
Arthur Miller in Death of a Salesman
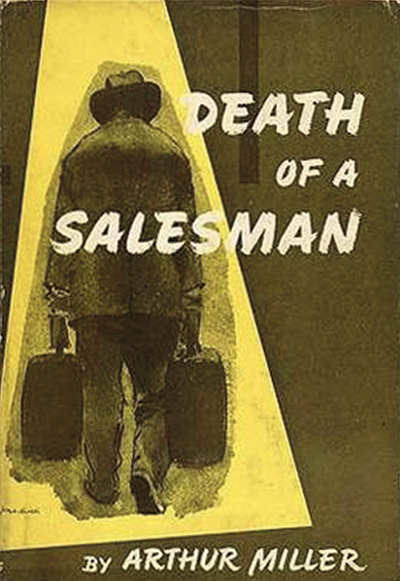
Alberto Cantoni
Socio ALDAI-Federmanager componente del Gruppo Cultura
Non sempre l’Europa è stata molto attenta alle parole e ai fatti che dall’altra parte dell’Atlantico stavano costruendo un modello di società e di cultura i cui differenti aspetti oggi non sembrano entusiasmare più del dovuto e forse sono ancora troppo poco indagati per essere verità.
La cultura prestigiosa del Novecento americano è stata spesso messa in ombra dal successo economico e dai modelli politici che hanno fatto storia, e solo nei tragici momenti di guerra in Italia, grazie all’illuminata volontà della Casa Einaudi, Cesare Pavese usciva nel 1942 con la sua traduzione di The Hamlet (1931) di Faulkner ripreso con intelligente mossa da Adelphi nel 2005.
Sorge spontanea una domanda: è stata troppo dominante la cultura europea e troppo lontana la voce di una realtà sociale immensa e multietnica, capace di offrire possibilità a piccoli e grandi che in essa si rifugiavano per fame, per paura del degrado europeo oppure per intelligente visione del mondo che in essa progrediva? Lasciare in ombra le parole e le opere che in tale spazio di popoli si sono realizzate, oltre l’economia e la scienza, nella letteratura e nella pittura con voce sempre dirompente e spesso opposta a quanto è stato chiamato il Sogno Americano, non ha comunque impedito che nel dopoguerra sia stata fatta giustizia e i valori più veri siano emersi in tutta la loro completezza.
Una cultura, quella americana, che ha saputo ritrovare l’antica e presente storia dell’occidente europeo e ha potuto e voluto creare un suo modello di tradizione e innovazione, di cinema e teatro, di propaganda e verità. Un modello con estremi contrasti e profondi valori che si sono diffusi nel mondo intero e che di certo non si faranno cancellare dal presente populismo a cui assistiamo non senza colpe personali.
La cultura prestigiosa del Novecento americano è stata spesso messa in ombra dal successo economico e dai modelli politici che hanno fatto storia, e solo nei tragici momenti di guerra in Italia, grazie all’illuminata volontà della Casa Einaudi, Cesare Pavese usciva nel 1942 con la sua traduzione di The Hamlet (1931) di Faulkner ripreso con intelligente mossa da Adelphi nel 2005.
Sorge spontanea una domanda: è stata troppo dominante la cultura europea e troppo lontana la voce di una realtà sociale immensa e multietnica, capace di offrire possibilità a piccoli e grandi che in essa si rifugiavano per fame, per paura del degrado europeo oppure per intelligente visione del mondo che in essa progrediva? Lasciare in ombra le parole e le opere che in tale spazio di popoli si sono realizzate, oltre l’economia e la scienza, nella letteratura e nella pittura con voce sempre dirompente e spesso opposta a quanto è stato chiamato il Sogno Americano, non ha comunque impedito che nel dopoguerra sia stata fatta giustizia e i valori più veri siano emersi in tutta la loro completezza.
Una cultura, quella americana, che ha saputo ritrovare l’antica e presente storia dell’occidente europeo e ha potuto e voluto creare un suo modello di tradizione e innovazione, di cinema e teatro, di propaganda e verità. Un modello con estremi contrasti e profondi valori che si sono diffusi nel mondo intero e che di certo non si faranno cancellare dal presente populismo a cui assistiamo non senza colpe personali.
Arthur Miller (1915-2005), ebreo di New York, ne è il tipico esempio in tutte le sue contraddizioni e valori. Non tradizionalmente accademico, ma legato strettamente al mondo universitario, non esponente politico, ma non sottomesso al dover essere solo e unicamente “americano” e non capace di creare un modello di cultura che avrebbe potuto essere una delle grandi voci dell’Occidente, egli ha comunque saputo tracciare nei più duri momenti della Guerra Fredda un percorso di critica sociale e comportamentale che ha lasciato a noi tutti in dono un modo nuovo di fare teatro. Ha saputo presentare un sistema e smentire un modo di vivere dove l’orgoglio del successo e della ricchezza, nella società del benessere, avrebbe dovuto fare di un uomo un essere vincente e rendere estraneo il debole e lo sconfitto. Pur nei contrasti dei suoi pubblici atteggiamenti, forse americani in tutto, e nello scadere della sua vena drammaturgica dopo i successi degli Anni ’50, le tematiche trattate da Miller nei suoi primi lavori e il riconoscimento che hanno ricevuto non sono poca cosa, e non lasciano nel silenzio il fatto che è sempre esistito un dramma umano che il successo e la ricchezza non hanno saputo e voluto affrontare e risolvere.
Death of a Salesman (1949) non è di certo il racconto teatrale della sconfitta di una famiglia perdente nel mondo governato dalle leggi del mercato, ma un’accorata testimonianza che l’essere umano ha la sua storia personale, che il mondo del lavoro è in tutto parte del mondo individuale e che di fallimento si può morire più che di malattia.
Dedicare tutta la vita al lavoro in posizione di rappresentante commerciale nella ricerca di un successo riconosciuto dai proprietari dell’azienda fino a immaginare di divenirvi anche piccolo partecipe del capitale aziendale è stato un fatale errore e occasione di tradimento di ogni speranza. Lo scorrere degli eventi non descrive un modello di lavoro fra azienda e mercato, ma spinge a riflettere come sia importante non confondere progresso economico con progresso sociale, a non distogliere lo sguardo dal tempo familiare per dare evidenza del tempo lavorativo e soprattutto a non ignorare che i fatti della vita sono molto più amari di quanto l’apparenza sociopolitica di un popolo passa fare credere. Al fatale suicidio, forse neppure direttamente cercato, del commesso viaggiatore al termine della sua fallimentare esperienza lavorativa e familiare segue una terribile verità. Dopo il funerale del marito, che ha difeso in tutta la sua vita con fedeltà, la moglie sorpresa e incredula dichiara di “non sentire dolore”. Tanto schiaccianti erano stati i fatti precedenti la fine di una convivenza di sacrifici e speranze che la persona più coinvolta e che ne è sopravvissuta non riesce a distinguere il dramma dei fatti dal dolore dell’intimo personale. Quasi a voler dire che la vita, dove regna l’avere e non l’essere (Eric Fromm), è tale per cui la persona viene disumanizzata e deve rimettere insieme i pezzi che si sono rovinati per continuare a vivere nello stesso mondo che ha portato rovina. Non c’è spazio alla speranza nella realtà che ci circonda e che noi sosteniamo con le nostre scelte di competizione e non di condivisione.
Arthur Miller è stato un simbolo di opposizione nell’America degli Anni ’50 perché ha avuto il coraggio, l’interesse e spesso la convenienza personale di affrontare i lati oscuri del Sogno Americano tanto propagandato dagli organi ufficiali pubblici e privati. Partendo da una visione politica molto lontana dalle regole della Guerra Fredda e facendo leva sulla sua indiscussa capacità di coinvolgere il lettore e lo spettatore nei problemi socioeconomici del suo tempo, Miller ha toccato il nervo scoperto della contraddizione fra il potere e il danaro contro l’etica sociale e la dignità della persona umana in una società dove chi ha avuto successo è per definizione un esempio da seguire.
Morte di un commesso viaggiatore (Death of a Salesman) si pone come amara descrizione della miseria in cui può finire una vita di lavoro e di sacrificio quando i sogni e la realtà non si trovano sulla stessa lunghezza d’onda e quando non si può contare su appoggi solidi per essere difesi dalla prevaricazione dei più forti. Debolezza non significa innocenza e forza non significa colpevolezza, ma il forte prevarica il debole e il debole non può che soccombere, lasciando che i segni tanto evidenti del dolore umano si diffondano nella società che ci circonda e rimangano senza risposta. Una letteratura incalzante quella di Miller, priva a volte di quello spessore che meriterebbero gli argomenti da lui trattati con reale senso del teatro del Novecento americano.
SAVE THE DATE
L’incontro dedicato a Morte di un commesso viaggiatore si terrà
mercoledì 17 settembre 2025
alle ore 17:00 in ALDAI, in Sala Viscontea Sergio Zeme
Per partecipare è necessaria la registrazione su www.aldai.it
01 luglio 2025
 Localizza
Localizza 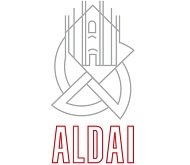




 Stampa
Stampa
 WhatsApp
WhatsApp













