La Poesia Americana nel cuore del Novecento
Per il ciclo “Dalla Lost Generation alla Beat Generation: la letteratura USA 1920-1950”

Walter Whitman, noto come Walt Whitman (Huntington, 31 maggio 1819 – Camden, 26 marzo 1892), è stato un poeta, scrittore e giornalista statunitense. Foto conservata della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d’America, Divisione Stampe e Fotografie (Prints and Photographs Division). Pubblicata su Wikipedia
Daniela Savini e Alberto Cantoni
Componenti del Gruppo Cultura ALDAI-Federmanager
Parlare di poesia americana – o più precisamente di poesia nordamericana in lingua inglese degli anni centrali del Novecento, con la voce dell’occidente europeo – è cosa difficile e potrebbe condurre a una visione troppo limitata di quanto è avvenuto per un nuovo modo di fare cultura in un immenso Paese che ha sempre trovato in sé tutte le forze per reagire al conformismo e alla superficialità di cui spesso viene tacciato.
È un fatto che la poesia europea trova nella sua lunga storia tutti i fondamentali per essere un valore riconoscibile e non imitabile. Le liriche della Grecia antica come l’eredità del Cantico dei Cantici, la perfezione linguistica di Leopardi, le Elegie Duinesi di Rilke o le immagini della Divina Commedia dantesca sono premessa e ragione dell’inarrivabile lucidità delle mancate Lezioni Americane di Calvino, che fondano la loro leggerezza nelle dantesche immagini che parlano di Guido Cavalcanti, del doloroso raccontare di Paul Celan della spiaggia bretone dove gli “accadde il mondo” e dell’amaro dolore di Ungaretti sull’aspra roccia del Carso.
Una lunga storia di stile e pensiero che si sposa in tutto nel nuovo che sta per realizzarsi, permette continuità e innovazione, sottili dettagli di voci come fulmineo apparire di immagini tradotte in parole. È un fatto acquisito, in Europa siamo troppo spesso convinti e con ragioni non trascurabili di essere un punto di non ritorno, un modello superiore, una civiltà che può solo molto dare e poco ricevere.
Una lunga storia di stile e pensiero che si sposa in tutto nel nuovo che sta per realizzarsi, permette continuità e innovazione, sottili dettagli di voci come fulmineo apparire di immagini tradotte in parole. È un fatto acquisito, in Europa siamo troppo spesso convinti e con ragioni non trascurabili di essere un punto di non ritorno, un modello superiore, una civiltà che può solo molto dare e poco ricevere.
Se troviamo invece il coraggio di pensare con mente libera quanto altri hanno fatto, quanto proprio la cultura europea ha saputo generare in popoli a noi vicini, ma diversi per storia e tradizioni, figli dell’Europa ma non più da noi condizionati, allora è possibile vedere che anche nell’America che oggi sbanda paurosamente nell’arroganza di populismi, di cui anche noi soffriamo, è avvenuto un cammino di illuminata cultura. Dalle altisonanti voci di esaltazione nazionale di Walt Whitman alle ormai consumate descrizioni funebri della Spoon River Anthology, un nuovo popolo ha saputo appoggiare i propri piedi sulla storia europea e tracciare un percorso verso un modo di fare poesia spesso fulminante e carnale, vincente e sconfitto, radicale e prolisso come mai in un’isolata Europa si sarebbe potuto realizzare.
Nasce così dalla generazione del tardo Ottocento, in quegli States che stavano realizzando una vera rivoluzione socio-industriale, finita poi anche in grande depressione, un modo di fare cultura che, appoggiandosi alla tradizione europea e spesso con essa fondendosi, genera una poesia nuova, ricca di simboli e di immagini, vissuta in prima persona come voce travolgente e colma di quell’intuizione lirica che può trasformare la realtà in fatti e i fatti in parole, ossia in poesia.
Nel momento in cui tutto sembrava essere mutabile, anche la voce della cultura afro-americana cerca di forzare le barriere dell’esclusione e sul fiume Mississippi, diretto in Messico, Langston Hughes scrive The Negro speaks of River, antecedente dei movimenti di liberazione che tanta tragedia hanno subito nell’America dei conservatori. Appare nel 1922 The Waste Land di T.S. Eliot, americano naturalizzato inglese e Premio Nobel 1948 per la letteratura, pagine ricche di immagini improvvise, di modelli danteschi, della Bibbia e della leggenda del Graal. Poesia trasformata da Ezra Pound – “il miglior artigiano” – da convulso aggregato di parole e simboli nella più lacerante disillusione di un’umanità che non sapeva trovare consistenza e ha dimostrato con i fatti che stava dicendo il vero.
Quando tutto sembrava ormai avvenuto, ecco che si sono alzate le voci di Robert Frost, americano di San Francisco diventato immagine simbolo del raffinato New Englander e vincitore di svariati Pulitzer Price, e di Wallace Stevens avvocato e top manager che ha vissuto di poesia nell’intimità del suo tempo libero. Dominante è stata anche la presenza dello stesso Pound, pellegrino in Europa e rifiutato in America con tutto il suo bagaglio dantesco, e di William Carlos Williams, simbolo di un popolo multietnico che trasferiva l’angoscia del vivere cittadino in sogno di libertà nelle immense distese della campagna americana, ricca per pochi e povera per molti fino alla schiavitù. Con loro anche Hilda Doolittle, nostalgica del magico ellenismo antico, e Marianne Moore, artefice di quel rinnovamento letterario che poneva la parola come vero senso delle cose. Siamo nei momenti più tragici per il mondo intero, la devastazione della Seconda Guerra mondiale, ma in America è avvenuto come in Europa il miracolo di nuove voci che si alzano libere di dire e tracciare una strada tutta personale e avvolgente, una strada che con l’Europa tutto incrocia e confronta, ma si pone e rimane indipendente.
Ci troviamo così davanti alla realtà del Black Mountain College, una comunità culturale e universitaria dove il lavoro e la cultura progredivano al passo di nuove ricerche. Riflessioni sul colore e sulla non forma pittorica, sul rumore trasformato in suono di John Cage, sulla danza immobile di Merce Cunningham con la voce poetica e frammentaria di Robert Duncan, Denise Levertov, europea naturalizzata americana per vocazione, e di Robert Creeley. La loro sensuale musicalità sarà poi oggetto di profonda riflessione nelle nuove generazioni che apriranno la strada al secondo Novecento, regno dell’arte globale. Da San Francisco, Lawrence Ferlinghetti con il City Ligths Bookstore diviene simbolo della Beat Generation in cui troveranno spazio di pensiero e di parola quanto in apparenza è sembrato allucinato, ma in realtà vivido e reale, il ritmico incalzare con frenetico bebop di Howl di Allen Ginsberg e la convulsa Bomb di Gregory Corso. Senza mezzi termini si dichiara che non è la bomba che scoppia, ma è la persona umana che vuole farla scoppiare e quindi deve essere del tutto responsabile dei suoi effetti senza falsi compromessi politico economici.
Nel cuore del Novecento la poesia è ormai un modo di essere, una voce di ribellione e di pace con cui tutto può essere detto e negato. Sylvia Plath in Daddy si libera, almeno crede, del dominio nazista del padre e Woody Allen, con attenta e sottile finezza, fa parlare in Hannah and her Sisters la sensuale e impercettibile voce di E.E. Cummings in cui “not even the rain has such small hands”. Il mondo e non solo l’America sono entrati nel secondo Novecento e di questo parleremo in altra sede.
SAVE THE DATE
L'incontro La Poesia Americana nel cuore del Novecento si terrà
mercoledì 5 novembre alle ore 17 in Sala Viscontea Sergio Zeme.
Per partecipare è necessaria la registrazione su www.aldai.it
01 ottobre 2025
 Localizza
Localizza 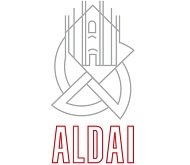




 Stampa
Stampa
 WhatsApp
WhatsApp













