L’erosione delle pensioni e l’eredità di Colbert
Quando i Governi continuano a spennare l’oca senza provocare troppi strepiti.
Ceto medio e pensionati sotto pressione: tasse elevate, perequazione ridotta
e potere d’acquisto in calo. Senza una risposta unitaria, il declino non trova fine
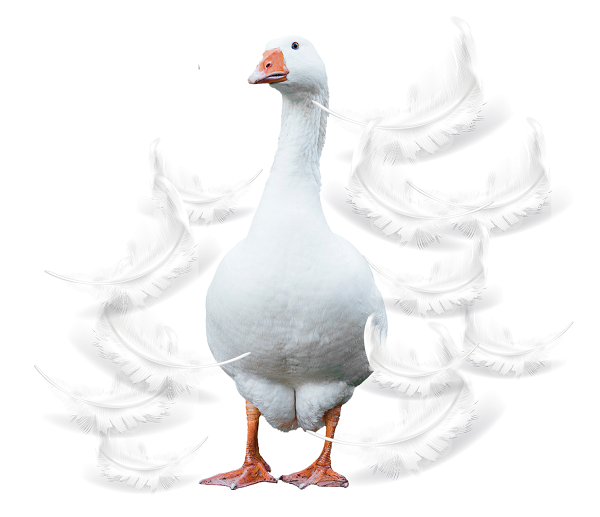
Antonio Dentato
Componente Sezione Pensionati Assidifer - Federmanager
È celebre l’espressione attribuita a Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), ministro delle Finanze di Luigi XIV: “L’arte di tassare consiste nello spennare l’oca ottenendo il maggior numero possibile di piume con il minor numero di starnazzi”.
Un principio che sintetizza una strategia fiscale volta a massimizzare il gettito erariale senza provocare proteste eccessive. Nel breve periodo, la politica di Colbert rafforzò le finanze statali, ma creò un sistema oppressivo che aggravò le disuguaglianze sociali. Quel metodo funzionò fino a quando la popolazione accettò passivamente il prelievo, ma nel lungo periodo alimentò tensioni. Complici altri eventi sociali, economici, politici, la Francia via via esaurì i tempi di maggiore splendore: conflitti e scontri sociali, politici, religiosi per culminare in eventi storici drammatici.
Fatti del passato. Fortunatamente, le conquiste sociali e i meccanismi della democrazia moderna offrono numerosi strumenti di tutela. I sistemi di governo sono gestiti mediante il bilanciamento dei poteri. Con il passare del tempo, la lezione di Montesquieu (1689-1755) – De l’esprit des lois, 1748 – sulla separazione dei poteri e la prevenzione degli abusi dell’autorità è divenuta il pilastro su cui si fondano gli Stati democratici moderni. Tuttavia, la storia dimostra anche che, in sistemi avanzati, alcune scelte di governo tendono a travalicare principi di fondo, forzano la mano e penalizzano le categorie sociali meno compatte e prive di una rappresentanza forte.
La crisi del ceto medio
Il ceto medio da anni subisce un progressivo logoramento senza
riuscire a sviluppare una reale capacità di opposizione contro misure che lo penalizzano. Lo evidenzia il Rapporto Censis-CIDA di maggio 2024, che fotografa una classe media in continuo arretramento: professionisti, imprenditori e lavoratori qualificati affrontano un costante impoverimento e una crescente perdita di fiducia nel futuro.
La frammentazione e una rappresentanza anch’essa non sempre impegnata sugli stessi obiettivi favoriscono una disgregazione che paralizza qualsiasi iniziativa incisiva.
CIDA ha cercato di rompere questa inerzia lanciando la petizione Salviamo il ceto medio, per denunciare anni di vessazioni fiscali e previdenziali. Un’adesione più massiccia avrebbe dimostrato che il ceto medio non è inevitabilmente destinato alla rassegnazione.
Il punto cruciale è proprio questo: il ceto medio, pur avendo un ruolo determinante nello sviluppo economico e nell’equilibrio sociale, fatica a far sentire la propria voce. Il rispetto delle istituzioni è un valore, ma il silenzio prolungato può trasformarsi in un boomerang. Se la storia insegna qualcosa, è che chi non difende i propri interessi, e soprattutto i propri diritti, finisce per pagarne le conseguenze. Gli strumenti democratici esistono e vanno usati. Serve una consapevolezza nuova: solo attraverso una partecipazione attiva e rafforzando una rappresentanza che possa agire in maniera più incisiva è possibile invertire la rotta.
Pensionati del ceto medio
Le considerazioni appena esposte relative al ceto medio valgono, e in alcuni aspetti si fanno ancora più stringenti, per una categoria specifica all’interno di questa classe sociale: i pensionati, fascia per antonomasia fragile per età e per impossibilità di adeguamento del reddito da altre attività.
Negli ultimi 25 anni, i pensionati del ceto medio sono stati oggetto di continui interventi penalizzanti. I loro trattamenti sono stati ripetutamente colpiti dall’uso della cosiddetta “contribuzione di solidarietà”, spesso accompagnata da misure di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni, attraverso blocchi totali o modifiche peggiorative del meccanismo perequativo.
La Corte Costituzionale ha affermato, anni addietro, che il blocco della perequazione incide su una fascia della popolazione particolarmente debole, “priva di strumenti di adeguamento del reddito”, osservando che i redditi pensionistici, per la loro natura, non possono essere trattati come minoris generis rispetto ad altri redditi da lavoro, poiché la Costituzione (art. 53) impone equità fiscale senza discriminazioni arbitrarie (Sentenza n. 116/2013). E, intanto, non ha mancato di segnalare che il ripetersi di provvedimenti riduttivi evidenzia “il carattere sempre più strutturale del meccanismo di azzeramento della rivalutazione e non quello di misura eccezionale, non reiterabile”. Ha chiarito che “il mancato adeguamento delle retribuzioni equivale a una loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non essendo previsto alcun meccanismo di recupero”, con una conseguente violazione degli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione (Sentenza n. 70/2015).
Osservazione ripresa nella Sentenza n. 234/2020. Riappare però in termini alquanto critici nell’ultima pronuncia della Corte, la sentenza n. 19/2025, dove, a fronte del principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma Cost., viene escluso che questo comporti la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici. Piuttosto il richiamo è a precedenti sentenze, di tutt’altro tono, nelle quali si afferma che le pensioni più elevate presentano maggiori margini di resistenza agli effetti dell’inflazione.
Osservazione perfino accettabile, se la misura fosse applicata una tantum, ma è misura divenuta strutturale, come pure la stessa Corte ha rilevato (vedi pagina precedente). Allora il tacito consenso diventa più difficile. Specie se si tratta del settimo provvedimento emanato in poco più di 20 anni. E l’ottavo è anch’esso in corso, peraltro più grave, perché se la prende con una minoranza di poche decine di migliaia di individui, persone piuttosto avanti negli anni: pensionati, cittadini italiani, residenti all’estero. E questo in palese violazione di principi costituzionali, norme di diritto europeo e di Convenzioni internazionali. La discriminazione è nella Legge di Bilancio n. 207/2024, art. 1, c. 180.
Al di là di quest’ultimo intervento punitivo che merita una trattazione a parte, intanto, di fronte ai ripetuti interventi restrittivi, i pensionati hanno presentato ricorsi presso i tribunali ordinari e le sezioni della Corte dei Conti regionali. Molti di questi ricorsi sono stati successivamente esaminati dalla Corte Costituzionale. Purtroppo, per la quasi totalità respinti. In effetti a partire dalla seconda metà degli anni ’80, la Corte ha fornito il proprio contributo per invertire le spinte espansionistiche insite nel sistema, privilegiando il principio del bilanciamento tra i diversi interessi costituzionali e le compatibilità economico-finanziarie dello Stato1. Ma questo non può costituire motivo sufficiente per dire basta, fermiamoci, non serve continuare a insistere.
L’importanza dei ricorsi e il rischio mortale del silenzio
I ricorsi, infatti, non sono solo strumenti utili per ottenere, per quanto possibile, una sentenza favorevole. Sono molto di più: sono un mezzo indispensabile per richiamare l’attenzione pubblica e politica sugli effetti gravi delle misure che, da anni, penalizzano sistematicamente i pensionati. Ogni iniziativa giudiziaria stimola valutazioni nella dottrina giuridica, nella politica, e contribuisce a rendere evidente la logica reiterata che considera le pensioni un comodo serbatoio di risorse da cui attingere facilmente per esigenze di bilancio.
E, tuttavia, i ricorsi, da soli, non bastano. Se possono correggere alcune distorsioni, non riescono a fermare la tendenza di fondo. Occorrono altri strumenti, innanzitutto politici. I pensionati devono essere consapevoli, ormai, che una volta andati in pensione non possono godersi pacificamente il frutto del loro impegno lavorativo e dell’ammontare dei tanti contributi previdenziali versati. Devono sapere che il loro reddito non sempre è protetto nel suo potere d’acquisto, perché è assoggettato a regole che non lo difendono in maniera definitiva e stabile. A fronte di questa situazione, occorrono iniziative che precedono gli interventi legislativi che riducono le pensioni o modificano in peggio il meccanismo di adeguamento all’inflazione.
Occorre rendersi attivi, presenti nelle fasi preparatorie delle leggi: mentre vengono elaborate, predisposte, dibattute. E questo avviene nelle sedi dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, nelle associazioni di categoria e, comunque, in tutti i luoghi dove è possibile mantenere contatti e confrontarsi con i decisori della politica. Sono i posti dove esprimere pubblicamente approvazione o dissenso. Insomma, sono le sedi nelle quali è possibile esporre argomenti a difesa dei redditi dei pensionati e, comunque, far sentire la propria voce.
Si dirà che un tale attivismo non è praticabile da chi è più anziano o fragile. E tuttavia, anche in queste condizioni è possibile partecipare. A parte quelli che decidono ostinatamente di farsi da parte e, indifferenti alle vicende sociali, attendono che altri si diano da fare anche per loro, va ricordato che la tecnologia ora mette a disposizione strumenti di partecipazione anche da remoto: partecipazione a dibattiti, assemblee, conferenze promosse da associazioni e sindacati. E, infine, è possibile intervenire sui media e sui social.
È questione complessa, quella qui sollevata. Oggetto di possibili critiche e di argomentazioni contrarie. Ma è, comunque, tema che non possiamo più eludere.
Perché se la politica continua a restare sorda a tanti richiami, e se le organizzazioni sindacali e sociali incontrano difficoltà nel farsi ascoltare, ciò avviene anche a causa del silenzio degli interessati.
L’assenza di una reazione collettiva, forte e continuativa, alimenta l’idea che si possano imporre restrizioni sempre maggiori a questa categoria senza incontrare una reale opposizione. È lo stesso schema che colpisce il ceto medio nel suo complesso: la sua frammentazione sociale e politica lo mette in una posizione di non ascolto, marginale.
Conclusione
A quasi quattro secoli di distanza, sembra ancora attuale la spietata logica fiscale del “colbertismo” che punta a recuperare risorse il più possibile, cercando al contempo di limitare le reazioni di chi paga. La storia insegna che i diritti non vengono concessi, ma difesi. E difesi ogni giorno. Il silenzio non protegge. Per questo non è solo il tempo dei pensionati, ma di tutto il ceto medio, che deve riscoprire la forza del confronto, della partecipazione e della mobilitazione con tutti gli strumenti offerti dall’ordinamento democratico. Occorre che il ceto medio e la sua componente di pensionati, da troppo tempo bersagli facili di politiche inique, facciano sentire con maggiore vigore la propria voce, in modo chiaro, continuo e determinato. È urgente.
1) Camera dei Deputati, Documentazione parlamentare, focus 5 luglio 2022, Politiche per il lavoro e previdenziali, Giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale.
01 aprile 2025
 Localizza
Localizza 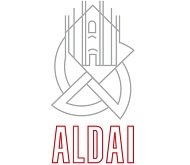




 Stampa
Stampa
 WhatsApp
WhatsApp










