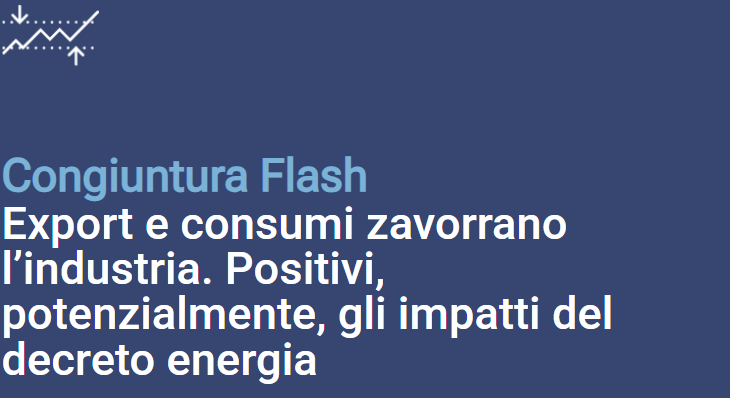Caravaggio, il colore del tormento
La palla rotola lontana dal campo, nessuno se ne cura più perché quei due stanno litigando, una spinta, una mala parola. Gli amici li dividono e la questione sembra finita. Ma non è così: qualche giorno dopo, quando i due si rincontrano per caso, la miccia si consuma e la rissa è quasi scontata.

Caravaggio, San Girolamo, Galleria Borghese, Roma.
Silvia Bolzoni
I due “valenthuomini” sono Ranuccio Tomassoni e Michelangelo Merisi. Che sia stato per un fatto di gioco o di passione, ormai, poco importa. Le storie su quel 28 giugno 1606 si rincorrono, le ipotesi si moltiplicano, ogni tanto spunta un documento d’archivio ad avallare questa o quella tesi.Un fatto rimane certo: Michelangelo, con una condanna capitale sulla testa, deve fuggire da Roma, dove non tornerà più. Scappa a Napoli prima, poi a Malta nel 1607, forse in cerca di redenzione e pace dai tormenti che lo perseguitano da sempre. Vuole farsi cavaliere. Ci riesce. Ma anche sull’isola la pace dura poco, ancora una rissa e deve fuggire di nuovo, in Sicilia. Da lì ancora a Napoli. Si è accesa una speranza, qualcuno lo informa che gli amici non hanno smesso di chiedere la grazia per l’omicidio del Tomassoni e quasi quasi il nuovo Papa è disposto a concederla. Roma, si torna a casa. Ma no, il destino lo vede naufrago a Porto Ercole, nel 1610. Degna fine romantica per un genio del Barocco.
Questi quattro anni si possono considerare la forma conclusiva e visibile del suo viaggio interiore, un tormentoso peregrinare tra i moti dell’animo, tra luci e ombre, ombre che servono a custodire la luce come un bene prezioso, ombre che sono tende e drappeggi che appena scostati fanno penetrare raggi densi di pulviscolo, tangibili, e rendono i colori più squillanti.
Non sarà neppure un caso che tra i colori, quello che più spicca è il rosso: vibra di mille sfumature, più di ogni altro: dal rubino al porpora, dal bordeaux all’amaranto, si piega a farsi materia pura, dal velluto al lampasso al sangue. Caravaggio, il sangue, lo dipinge che scende in gocce dalle teste mozzate di Golia, che schizza potente da quella di Oloferne, già raffermo in quella del Battista sul piatto e infine come una pozzanghera che si forma mentre la spada cala sul collo di Giovanni. L’unica firma che lascia la mette proprio lì, in una pozzanghera.
E poi c’è la carne, l’indefinibile colore della carne: i gialli, gli arancioni, i bruni, persino i verdastri usati per i cadaveri: tutti lumeggiati dai bianchi, che squarciano neri e marroni e s’imprimono negli occhi, flash antelitteram, e lì, sulla retina rimangono per un po’. Le carni macilente dei San Gerolamo e quelle sode del Battista, corpi vecchi e giovani che vengono plasmati tridimensionalmente, indagati nelle pieghe della pelle, nel tendersi dei muscoli, nell’affiorare di clavicole, omeri e tendini.

Caravaggio, Giuditta e Oloferne, Palazzo Barberini, Roma.
Tutto è indagato con lo scrupolo della verità, sulla scia di quel naturalismo lombardo – nasce in provincia di Bergamo, si forma a bottega a Milano, enfant prodige visto che il suo apprendistato inizia a soli 11 anni – nel quale si è formato e che viene ora portato allo spasimo delle bocche urlanti di Medusa e Isacco, nella mano tesa dell’uomo a cui viene cavato un dente o ancora – scandalo! – nel ventre gonfio di una Maria, morta, anzi assopita in un sonno profondissimo, secondo l’iconografia orientale della Dormitio, in attesa di essere assunta in cielo ma ancora donna in carne e ossa.
Questi i tratti dello stile che spaventò molti contemporanei, non riuscendo a comprenderlo, ma anche della grandezza del Merisi e della lezione che senza volere diede a tanti seguaci più o meno dotati, pittori che lo imitavano ancora lui in vita e che rielaborando il suo peculiare linguaggio diedero nuova linfa alla pittura europea e portarono la novità da Roma alla Spagna, lì accolta da Velazquez e Zurbaran, e al Nord, nelle Fiandre, ripresa da Rembrandt e ancora prima da Rubens. Anzi, proprio Rubens, di pochi anni più giovane di Caravaggio, riuscì a comprendere la portata della rivoluzione innescata dal Merisi e non perse l’occasione di assolvere ai suoi compiti di segugio d’arte comprando per il suo signore, Vincenzo Gonzaga, al prezzo di 180 scudi d’oro, proprio il suo ultimo dipinto romano, disponibile sul mercato perché rifiutato dai committenti, la “Morte della Vergine”.
Tutto, dai colori ai soggetti, dal modo di dipingere alle vicende personali, ci porta nella leggenda del pittore ribelle, violento, del “maudit”. Non solo per noi, lontani ormai più di 400 anni, ma anche per i contemporanei.
Del Merisi si è parlato sempre e da subito, anche se con alterni giudizi: Baglioni, rivale ed epigono, gli dedica una biografia già nel 1642; Bellori, indiscussa voce legiferante sull’arte nel XVII secolo, nel 1672 lo critica ferocemente affermando come sia un pittore “povero d’inventione, senza decoro e senz’arte”, condannandolo all’oblio, almeno in Italia (e si sa come nessuno sia profeta in patria), fino alla grande stagione degli studi caravaggeschi del ‘900 che avranno il loro culmine nella grande mostra di Roberto Longhi a Palazzo Reale, a Milano nel 1951, pietra d’angolo su cui bisognerà poggiarsi da allora in poi.
Cosa che certamente avrà fatto anche la curatrice della mostra tanto attesa in questi mesi, Rossella Vodret, che presenterà i risultati delle ricerche degli ultimi anni, per il grande ritorno di Caravaggio a Milano.
Questi i tratti dello stile che spaventò molti contemporanei, non riuscendo a comprenderlo, ma anche della grandezza del Merisi e della lezione che senza volere diede a tanti seguaci più o meno dotati, pittori che lo imitavano ancora lui in vita e che rielaborando il suo peculiare linguaggio diedero nuova linfa alla pittura europea e portarono la novità da Roma alla Spagna, lì accolta da Velazquez e Zurbaran, e al Nord, nelle Fiandre, ripresa da Rembrandt e ancora prima da Rubens. Anzi, proprio Rubens, di pochi anni più giovane di Caravaggio, riuscì a comprendere la portata della rivoluzione innescata dal Merisi e non perse l’occasione di assolvere ai suoi compiti di segugio d’arte comprando per il suo signore, Vincenzo Gonzaga, al prezzo di 180 scudi d’oro, proprio il suo ultimo dipinto romano, disponibile sul mercato perché rifiutato dai committenti, la “Morte della Vergine”.
Tutto, dai colori ai soggetti, dal modo di dipingere alle vicende personali, ci porta nella leggenda del pittore ribelle, violento, del “maudit”. Non solo per noi, lontani ormai più di 400 anni, ma anche per i contemporanei.
Del Merisi si è parlato sempre e da subito, anche se con alterni giudizi: Baglioni, rivale ed epigono, gli dedica una biografia già nel 1642; Bellori, indiscussa voce legiferante sull’arte nel XVII secolo, nel 1672 lo critica ferocemente affermando come sia un pittore “povero d’inventione, senza decoro e senz’arte”, condannandolo all’oblio, almeno in Italia (e si sa come nessuno sia profeta in patria), fino alla grande stagione degli studi caravaggeschi del ‘900 che avranno il loro culmine nella grande mostra di Roberto Longhi a Palazzo Reale, a Milano nel 1951, pietra d’angolo su cui bisognerà poggiarsi da allora in poi.
Cosa che certamente avrà fatto anche la curatrice della mostra tanto attesa in questi mesi, Rossella Vodret, che presenterà i risultati delle ricerche degli ultimi anni, per il grande ritorno di Caravaggio a Milano.
01 ottobre 2017
 Localizza
Localizza 




 Stampa
Stampa
 WhatsApp
WhatsApp