Intelligenza artificiale e sicurezza fisica
Tra potenziale tecnologico e responsabilità etica

Stefano Diotti
Acre Security
Vicecoordinatore Gruppo Intelligenza Artificiale ALDAI-Federmanager
L'intelligenza artificiale (IA) è oggi uno dei principali motori di trasformazione in ambito tecnologico. La sua applicazione nel settore della sicurezza fisica – in particolare nella videosorveglianza e nel controllo accessi – ha introdotto cambiamenti profondi, accelerando l’automazione, aumentando l’efficienza e aprendo scenari completamente nuovi. Tuttavia, la fascinazione per il potenziale dell’IA deve essere accompagnata da una riflessione più ampia, che tenga conto dei limiti tecnici, delle implicazioni etiche e dei rischi sociali legati a un suo uso improprio o poco consapevole.
Non intelligenza, ma elaborazione evoluta
Nonostante il termine “intelligenza” artificiale suggerisca analogie con il pensiero umano, è importante sottolineare che questa tecnologia non è “intelligente” nel senso tradizionale. L’IA non ha coscienza, volontà o creatività. È un sistema statistico avanzato, basato su algoritmi di machine learning e deep learning, capaci di riconoscere pattern nei dati e restituire risultati coerenti in base all’addestramento ricevuto. A differenza dell’uomo, non immagina, non interpreta e non prende decisioni morali: si limita a eseguire calcoli in base alle informazioni che riceve.
Nel campo della sicurezza, questa caratteristica si traduce in strumenti che non “sostituiscono” il giudizio umano, ma lo supportano. Gli algoritmi non pensano, ma possono eseguire in modo estremamente efficiente operazioni come l’identificazione di oggetti o comportamenti sospetti, l’analisi di flussi video, la segmentazione di eventi.
Videosorveglianza intelligente e automazione
Tra le applicazioni più diffuse dell’IA in ambito sicurezza troviamo la videosorveglianza intelligente. Le telecamere moderne, dotate di capacità analitiche integrate, sono in grado di:
- rilevare oggetti in movimento in tempo reale;
- classificare persone, veicoli, animali o pacchi abbandonati;
- riconoscere comportamenti atipici (come corse, risse, cadute);
- leggere targhe o identificare volti con tecnologie biometriche;
- inviare segnalazioni automatiche in presenza di anomalie.
Queste funzioni non solo aumentano l’efficacia del monitoraggio, ma riducono drasticamente il carico cognitivo sugli operatori, che possono così concentrarsi su compiti più critici. Non è raro che un solo addetto debba sorvegliare decine o centinaia di telecamere: senza supporto algoritmico, il rischio di errore umano sarebbe elevato.
L’intelligenza artificiale sta anche abilitando nuove applicazioni, come il tracciamento delle persone all’interno di aree protette, la gestione di flussi nei luoghi pubblici o l’analisi predittiva per la prevenzione degli incidenti. Un sistema può oggi valutare la probabilità che un comportamento evolva in una situazione critica e inviare un alert prima ancora che si verifichi il danno.
Controllo accessi: prevenzione e personalizzazione
Anche nel controllo accessi, l’IA sta rivoluzionando le modalità di gestione. I sistemi intelligenti possono:
- riconoscere automaticamente un dipendente autorizzato mediante il volto o altri dati biometrici;
- impedire l’ingresso a soggetti sconosciuti o sospetti;
- bloccare l’accesso se il comportamento dell’utente risulta anomalo (ad esempio, accessi fuori orario o a zone non autorizzate);
- gestire badge temporanei in base al profilo del visitatore e all’orario previsto;
- verificare la corretta dotazione di dispositivi di protezione individuale (caschi, giubbotti, mascherine) prima di consentire l’ingresso in aree pericolose.
Queste automazioni aumentano la precisione del sistema e riducono al minimo gli interventi manuali, riducendo costi, errori e tempi di gestione.
L’illusione del controllo totale: da Minority Report alla realtà
Un riferimento immancabile quando si parla di IA e prevenzione dei crimini è il film Minority Report di Steven Spielberg, ispirato al racconto di Philip K. Dick. In quella storia distopica, la polizia è in grado di arrestare i colpevoli prima ancora che commettano un crimine, grazie a un sistema predittivo che anticipa le azioni umane.
Oggi, pur non disponendo di “veggenti digitali”, molte città stanno sperimentando strumenti di predizione del crimine. Sistemi di analisi dei dati e IA vengono utilizzati per prevenire furti o aggressioni, identificare potenziali minacce, ottimizzare le risorse delle forze dell’ordine. In Argentina, Regno Unito e Stati Uniti sono già operativi progetti pilota in cui l’IA segnala zone a rischio sulla base di statistiche, dati storici e comportamenti ricorrenti.
Ma l’idea di prevenire un reato prima che avvenga apre un terreno scivoloso. Chi garantisce che le decisioni automatizzate siano corrette? Che i dati non siano viziati da pregiudizi? Che la sorveglianza non diventi invasiva o discriminatoria? Proprio come nel film, il confine tra prevenzione e controllo può diventare labile se non accompagnato da una regolamentazione chiara e trasparente.
Il peso etico dell’innovazione
L’intelligenza artificiale, come ogni tecnologia, non è neutra. È progettata, addestrata e gestita da esseri umani, e come tale riflette le loro scelte, i loro bias e le loro priorità. Un algoritmo può, ad esempio, imparare a riconoscere volti con maggiore precisione su alcune etnie piuttosto che su altre, se i dati di training sono sbilanciati. Oppure può segnalare comportamenti normali come anomali se il contesto non è stato correttamente modellato.
Per questo, la responsabilità nell’uso dell’IA è un tema centrale. La ricerca più recente nel settore sottolinea come la maggior parte degli esperti consideri le considerazioni etiche e la trasparenza come priorità fondamentali. Molti intervistati temono che l’affidarsi all’IA per decisioni critiche possa portare a risultati inaffidabili o ingiusti. Altri temono violazioni della privacy, soprattutto in presenza di strumenti come il riconoscimento facciale o comportamentale.
Un tema ricorrente è anche la necessità di incorporare pratiche di IA responsabile fin dalle prime fasi di sviluppo, piuttosto che cercare di correggere gli effetti indesiderati a posteriori. Questo significa progettare algoritmi equi, trasparenti e sicuri, con una particolare attenzione alla protezione dei dati personali, al rispetto dei diritti individuali e alla tracciabilità delle decisioni automatizzate.
Regolamentazione e fiducia
La consapevolezza crescente del potere – e dei rischi – legati all’intelligenza artificiale ha portato all’avvio di numerose iniziative di regolamentazione a livello internazionale. L’obiettivo è creare un quadro normativo che, da un lato, garantisca l’innovazione, dall’altro protegga cittadini e istituzioni da usi impropri o eccessivamente intrusivi della tecnologia.
Un approccio equilibrato, che favorisca la fiducia senza rallentare il progresso, è considerato da molti la chiave per uno sviluppo sano del settore. In quest’ottica, le aziende del comparto sicurezza hanno la responsabilità di adottare politiche trasparenti e di comunicare con chiarezza le funzionalità – e i limiti – delle soluzioni basate su IA.
Conclusione
L’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per il mondo della sicurezza fisica: migliora l’efficienza, aumenta l’accuratezza, riduce il margine d’errore e libera risorse preziose per attività a maggior valore aggiunto. Ma proprio perché così potente, la sua applicazione richiede attenzione, visione e responsabilità.
Non stiamo costruendo “robot poliziotti” o sistemi infallibili: stiamo sviluppando strumenti di supporto che devono rimanere al servizio dell’uomo, non sostituirlo. Il ruolo dell’essere umano – nella progettazione, nel controllo, nella valutazione finale – resta insostituibile.
Solo in questo modo potremo davvero parlare di intelligenza artificiale al servizio della sicurezza: intelligente non perché prende decisioni da sola, ma perché aiuta le persone a prendere decisioni migliori, in modo più informato, rapido e sicuro.
Stefano Diotti
Business Development Manager South Europe presso Acre Security
Con oltre vent’anni di esperienza nel settore della sicurezza fisica e del controllo accessi, Stefano Diotti si occupa di sviluppo di business in Sud Europa per piattaforme di sicurezza Cloud Based. Attento alle implicazioni etiche delle tecnologie emergenti, affianca alla consulenza un’attività di divulgazione orientata alla responsabilità e all’innovazione sostenibile.
01 settembre 2025
 Localizza
Localizza 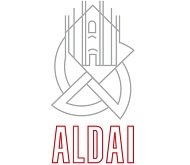




 Stampa
Stampa
 WhatsApp
WhatsApp

