L’era del disordine globale
L’Europa tra crisi e rinascita possibile

Foto di Gerd Altmann da Pixabay
Alfredo Avanzi
Ambasciatore Commissione Europea del Patto per il Clima - Socio ALDAI-Federmanager e componente dei Gruppi di Lavoro Energia ed Ecologia e CIDA Sviluppo Sostenibile
Viviamo in un’epoca di disordine permanente: guerre, crisi climatica, rivoluzione tecnologica. In questo scenario l’Europa, pur ricca di risorse e competenze, appare divisa e spesso irrilevante.
La dipendenza militare dagli Stati Uniti, il ritardo nell’innovazione digitale, la lentezza nelle scelte energetiche mostrano un continente più spettatore che attore. Eppure, abbiamo un mercato enorme, una moneta solida, capacità industriali diffuse. Ciò che manca è il coraggio politico: difesa comune, politica industriale condivisa, un titolo pubblico europeo.
Non è più solo una questione economica, ma di identità.
O l’Europa sceglie di contare, affrontando i nodi che la frenano, oppure resterà terreno di gioco per potenze altrui. Il tempo delle esitazioni è scaduto. Il futuro si costruisce adesso, oppure sarà il resto del mondo a deciderlo per noi.
Introduzione
Il nostro tempo viene sempre più descritto come un’epoca di “disordine strategico”. Non si tratta soltanto di una definizione suggestiva, ma di una cornice reale entro cui si muove la politica internazionale, l’economia mondiale e perfino la vita quotidiana dei cittadini. Le tensioni geopolitiche, le dicotomie irrisolte, l’instabilità finanziaria, i cambiamenti demografici e la crisi climatica stanno infatti convergendo, generando una complessità che non si era mai vista prima.
Se fino a pochi decenni fa era possibile distinguere chiaramente tra sfide politiche, sociali, economiche e ambientali, oggi questi elementi si intrecciano e si rafforzano a vicenda, creando una rete di crisi e di transizioni che spesso si sovrappongono. Ne derivano situazioni difficili da leggere, in cui anche i governi, le istituzioni più strutturate e il mondo imprenditoriale faticano a dare risposte rapide ed efficaci.
Rinunciare a comprendere questa complessità significherebbe condannarsi all’inerzia. Al contrario, serve uno sforzo di analisi e visione strategica: capire cosa sta accadendo, quali scenari si delineano e come le società possono reagire senza perdere fiducia nel futuro. Questa sfida riguarda in particolare l’Europa, che si trova oggi a un bivio storico.
Da un lato il rischio è evidente: il progressivo ridimensionamento del peso geopolitico europeo, unito alle divisioni interne e al rallentamento della crescita, può relegare il continente a un ruolo marginale nello scenario globale. Dall’altro lato, però, esistono anche opportunità straordinarie. La leadership normativa europea, la capacità tecnologica diffusa e il forte impegno verso la sostenibilità potrebbero diventare strumenti decisivi per rafforzare la sua posizione.
Il nodo centrale, quindi, non è soltanto comprendere la crisi, ma trasformarla in occasione di rilancio. Questo richiede un approccio capace di leggere il mondo in modo nuovo, abbandonando vecchie categorie politiche ed economiche e adottando logiche più integrate.
Fratture geopolitiche e nuove vulnerabilità
Il primo elemento da considerare è la trasformazione degli equilibri geopolitici. L’invasione russa dell’Ucraina ha riportato la guerra nel cuore dell’Europa, rompendo l’illusione di una pace stabile e definitiva che aveva accompagnato l’allargamento dell’Unione Europea. Questo conflitto, tuttavia, non è un evento isolato: si inserisce in una lunga serie di crisi che stanno ridisegnando la mappa del potere mondiale.
Una molteplicità di focolai
Oltre all’Europa orientale, il Medio Oriente resta un’area di tensione permanente, con conflitti irrisolti che coinvolgono attori regionali e potenze esterne. L’Indo-Pacifico, a sua volta, è diventato il nuovo epicentro della competizione tra Stati Uniti e Cina: dispute territoriali, militarizzazione delle rotte marittime e alleanze strategiche rendono la regione decisiva per il futuro del commercio globale. In Africa, infine, guerre civili, colpi di Stato e instabilità cronica alimentano flussi migratori e lotte per il controllo delle risorse.
Tutti questi fronti contribuiscono a un clima di incertezza permanente. Le catene del valore si spezzano e si ricompongono, le alleanze internazionali si ridefiniscono in modo spesso improvviso, e le regole del multilateralismo faticano a tenere il passo.
Il ruolo in trasformazione degli Stati Uniti
Gli Stati Uniti, tradizionalmente “arbitri” dei rapporti globali, stanno attraversando un momento di ripensamento. Il peso del debito pubblico, le difficoltà di consenso interno e il crescente costo degli impegni militari hanno ridotto la disponibilità di Washington ad assumersi la funzione di garante globale.
Un dato emblematico è il calo del peso del dollaro nelle riserve mondiali: secondo il Fondo Monetario Internazionale, nel 2023 esso è sceso al 58%, il livello più basso degli ultimi trent’anni. Questo indebolimento relativo, unito al crescente nazionalismo economico, spinge gli Stati Uniti a un atteggiamento più difensivo e meno orientato al multilateralismo.
L'ascesa della Cina

Fig. 1 - Influenza geoeconomia cinese Fonte stadafa.com da dati IMF, Eurostat, The World Bank
Dall’altra parte, la Cina si afferma come potenza economica (Fig.1) ed ecologica ormai paragonabile agli Stati Uniti. Il progetto della Nuova Via della Seta, gli accordi con oltre 120 Paesi e l’espansione militare nel Mar Cinese Meridionale mostrano una strategia chiara: consolidare il proprio ruolo come centro di riferimento non solo regionale, ma globale.
Il confronto con Washington assume così diverse forme passando dalla contrapposizione ideologica promossa da Biden, basata sulla narrativa democrazie vs. autocrazie, alla guerra commerciale iniziata sotto Trump. Per l’Europa questo significa trovarsi spesso in mezzo, costretta a prendere posizione o a subire le conseguenze delle scelte altrui.
La Russia tra revisionismo e risorse strategiche
Con l’aggressione dell’Ucraina, il Cremlino manifesta sempre più un revanscismo geografico e politico e, in prospettiva, un progetto di pressione intimidatoria sull’Europa.
Comunque, nonostante le difficoltà economiche per il conflitto e le sanzioni che ne sono conseguite, la Russia mantiene un peso rilevante grazie a tre fattori: la sua centralità come esportatore di energia, la posizione geografica strategica e le competenze militari e spaziali. L’alleanza, anche solo potenziale, con la Cina rafforza la sua capacità di condizionare l’equilibrio globale.
Il gruppo dei BRICS allargati (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, con l’ingresso di Egitto, Emirati, Etiopia e Iran) rappresenta già oggi oltre il 42% della popolazione mondiale e il 37% del PIL globale. Un blocco del genere, se consolidato, potrebbe diventare una sfida sistemica per l’Occidente e ridurre ulteriormente lo spazio di manovra europeo.
L’Europa tra reazione e protagonismo
In questo scenario, l’Europa si trova spesso relegata a un ruolo reattivo. Priva di una difesa comune e frammentata nelle politiche estere, fatica a incidere sui grandi dossier internazionali. Eppure, le sue risorse - economiche, tecnologiche e normative - restano considerevoli. La vera domanda è se sarà in grado di superare le proprie vulnerabilità e presentarsi come attore unitario, o se continuerà a muoversi in ordine sparso, dipendente dalle decisioni altrui.
Le grandi dicotomie del nostro tempo
Ogni epoca storica è stata segnata da contrasti che hanno definito il corso degli eventi. Durante la Guerra fredda, il mondo era diviso in due blocchi ideologici; nell’Ottocento, la contrapposizione era tra potenze coloniali e popoli colonizzati. La nostra epoca, invece, si caratterizza per una pluralità di dicotomie irrisolte che attraversano le società e ne determinano le traiettorie.
Questi conflitti non sono semplici divergenze di opinione: sono vere e proprie faglie, profonde, che separano visioni del mondo, interessi economici e generazioni. Analizzarle è fondamentale per comprendere le dinamiche globali e, soprattutto, per capire come l’Europa possa affrontarle senza restare paralizzata.
Sostenibilità vs. turbocapitalismo
La prima frattura riguarda il rapporto tra l’esigenza di costruire modelli di sviluppo sostenibili e la persistenza di logiche iper-capitalistiche. Da un lato, le nuove generazioni chiedono con forza un futuro ecologicamente ed economicamente equo; dall’altro, resiste un sistema orientato all’accumulazione rapida e all’affermazione individualistica.
Questa tensione si manifesta in molteplici settori. Ad esempio, la transizione energetica è vista da alcuni come una priorità etica e ambientale, ma da altri come un costo che frena la competitività industriale. Le resistenze ai cambiamenti climatici non sono solo culturali: derivano da interessi concreti di settori produttivi che temono di perdere profitti.
Autocrazie vs. democrazie
Un’altra contrapposizione cruciale riguarda i modelli politici. La contrapposizione tra regimi autoritari e sistemi democratici non è nuova, ma negli ultimi anni ha assunto nuove forme.
Le autocrazie - dalla Russia alla Cina, fino a diversi Paesi emergenti - si presentano come sistemi più “efficienti”, capaci di prendere decisioni rapide senza i vincoli dei processi democratici. Le democrazie, al contrario, sembrano spesso lente, divise e incapaci di rispondere a crisi complesse.
La sfida non è soltanto ideologica: riguarda anche la credibilità internazionale. Se le democrazie non riescono a garantire crescita, stabilità e inclusione, rischiano di perdere attrattiva nei confronti dei Paesi che devono scegliere i propri modelli di riferimento. Per l’Europa difendere la democrazia non significa solo riaffermare valori, ma dimostrare che questo modello può ancora produrre risultati concreti.
Sovranismo vs. globalizzazione
La globalizzazione, che sembrava inarrestabile, è oggi messa in discussione. Molti Paesi rivendicano un ritorno alla sovranità nazionale, come risposta a crisi che hanno mostrato i limiti delle interdipendenze globali.
La pandemia di Covid-19 ha reso evidente quanto fosse rischioso dipendere da catene di fornitura troppo lunghe e concentrate. Lo stesso vale per l’energia: la dipendenza europea dal gas russo ha mostrato la vulnerabilità di un sistema eccessivamente interconnesso.
Allo stesso tempo, fenomeni globali come il cambiamento climatico, le migrazioni o la regolazione del digitale dimostrano che nessun Paese, nemmeno i più grandi, può affrontarli da solo. La vera sfida è dunque trovare un equilibrio tra autonomia strategica e cooperazione globale.
Giovani vs. anziani
Mai come oggi la frattura generazionale è diventata visibile. I giovani chiedono opportunità, innovazione e sostenibilità, mentre le generazioni più anziane tendono a difendere status quo e sistemi di welfare che spesso finiscono per escludere i più giovani.
L’Europa, in particolare, deve affrontare un grave problema demografico: l’invecchiamento della popolazione. Questo crea squilibri nei sistemi pensionistici, nei mercati del lavoro e nelle priorità politiche. In molti Paesi, i giovani si sentono penalizzati, costretti a carriere precarie e con scarse prospettive di crescita.
La questione non è soltanto economica, ma anche culturale. Se le nuove generazioni percepiscono di non avere spazio per incidere, aumenta il rischio di disillusione, sfiducia nelle istituzioni e radicalizzazione politica.
Austerità vs. debito pubblico
Dopo la crisi del 2008, l’Europa ha adottato politiche di austerità per contenere la spesa pubblica. Ma negli ultimi anni, con la pandemia e la guerra in Ucraina, l’idea di sostenere l’economia tramite un uso più disinvolto del debito è tornata centrale.
Il problema è che entrambe le strade comportano rischi: l’austerità eccessiva frena la crescita e alimenta disuguaglianze, mentre un debito fuori controllo mette a rischio la stabilità finanziaria e la fiducia dei mercati.
L’Unione Europea deve quindi trovare un nuovo equilibrio fiscale, capace di sostenere investimenti strategici (in digitale, difesa, energia) senza compromettere la sostenibilità dei bilanci pubblici.
Intelligenza artificiale vs. intelligenza umana
La diffusione di tecnologie avanzate, in particolare l’intelligenza artificiale, solleva interrogativi profondi. Da un lato, l’IA promette efficienza, automazione e innovazione. Dall’altro, rischia di sostituire milioni di posti di lavoro e di aumentare le disuguaglianze.
La sfida non è soltanto economica, ma etica e culturale: fino a che punto siamo disposti a delegare alle macchine decisioni che riguardano la nostra vita? Come garantire che i benefici dell’innovazione siano distribuiti in modo equo?
L’Europa ha scelto di porsi come leader nella regolazione, elaborando il primo AI Act al mondo. Ma la domanda resta: riuscirà a trovare un equilibrio tra tutela dei cittadini e competitività industriale, senza perdere terreno rispetto a Stati Uniti e Cina?
Manifattura vs. Big Tech
Infine, un’ultima dicotomia riguarda il cuore dei sistemi produttivi. Da una parte c’è la manifattura tradizionale, ancora centrale in Europa e fonte di occupazione diffusa. Dall’altra ci sono le grandi piattaforme tecnologiche, che concentrano ricchezza e potere in poche mani, ridisegnando le regole dell’economia globale.
L’Europa, che storicamente ha puntato molto sull’industria manifatturiera, deve affrontare il rischio di essere schiacciata tra due modelli: da un lato quello americano, dominato dalle Big Tech, dall’altro quello cinese, basato su un capitalismo di Stato aggressivo. La sfida è integrare manifattura e tecnologia, creando un modello europeo di competizione sostenibile.
Dalla contrapposizione al pragmatismo
Queste dicotomie non devono essere viste come conflitti insanabili, ma come punti di tensione da cui può nascere innovazione. La vera sfida è trasformare il dualismo in nuove prospettive: conciliare sostenibilità e competitività, democrazia ed efficienza, autonomia e cooperazione.
Per riuscirci, l’Europa deve abbandonare la logica delle contrapposizioni rigide e adottare un approccio pragmatico, capace di valorizzare la complessità. Solo così la frammentazione del presente potrà diventare il terreno su cui costruire nuove forme di progresso.
Clima, risorse e demografia: le nuove linee di instabilità
Se il Novecento è stato il secolo delle ideologie e della contrapposizione militare, il XXI secolo rischia di essere ricordato come l’era delle crisi ambientali e demografiche. La questione climatica, le trasformazioni della popolazione mondiale e la competizione per le risorse naturali non sono problemi separati, ma tasselli di una stessa dinamica: la progressiva fragilità del sistema globale.
Il cambiamento climatico come fattore geopolitico
Per anni, il cambiamento climatico è stato percepito come un problema “lontano”, confinato a conferenze internazionali o a rapporti scientifici. Oggi, invece, i suoi effetti sono sotto gli occhi di tutti: ondate di calore sempre più frequenti, incendi devastanti, alluvioni improvvise, desertificazione progressiva.
Secondo i dati delle Nazioni Unite, circa il 70% delle catastrofi naturali degli ultimi vent’anni è legato a fenomeni climatici estremi. I danni economici ammontano a oltre 4,3 trilioni di dollari dal 2000, un costo enorme che colpisce in particolare i Paesi più vulnerabili, ma che non risparmia nemmeno le economie avanzate.
In Europa, l’OMS ha stimato che tra il 2022 e il 2023 le ondate di caldo hanno causato più di 100.000 decessi in 35 Paesi. Questi numeri mostrano chiaramente che la crisi climatica non è solo un tema ambientale, ma una vera e propria emergenza sanitaria, economica e politica.
L’acqua come nuova arma geopolitica
Il cambiamento climatico mette a rischio anche l’acqua: circa 2 miliardi di persone ne sono prive. I grandi fiumi internazionali sono spesso fonte di tensioni tra Stati, come nei casi del Nilo, del Gange e del Mekong. L’acqua sta diventando uno strumento geopolitico, e nei prossimi anni potrebbero emergere le “guerre dell’acqua”.
Migrazioni ambientali e pressioni demografiche
Il cambiamento climatico favorisce le migrazioni ambientali. Nel 2021, oltre 281 milioni di persone sono emigrate, molti per motivi ambientali come desertificazione e innalzamento dei mari. Il Sahel africano e l’Asia meridionale vedono crescenti spostamenti che pongono sfide ma anche opportunità, specialmente per l’Europa, che necessita di giovani lavoratori per sostenere crescita e welfare.
La corsa alle materie prime critiche
La transizione energetica ha acceso la competizione globale per minerali come litio, cobalto, terre rare e nichel, fondamentali per le tecnologie verdi. Produzione e raffinazione sono concentrate, con la Cina in posizione dominante, specialmente nelle terre rare. L’Africa, ricca di risorse come il cobalto, è al centro dell’interesse di potenze mondiali, con il rischio di nuove forme di neocolonialismo e instabilità regionale.
Energia e sicurezza: tre scenari per l’Europa
La transizione offre all’Europa opportunità e rischi. Tre possibili percorsi:
- Accelerazione verde: investire fortemente in rinnovabili e nucleare per ridurre la dipendenza esterna.
- Rallentamento strategico: diffidenza verso fornitori non affidabili porta a rallentamenti e maggiori costi.
- Transizione asimmetrica: priorità alla sicurezza nazionale può frammentare la coesione UE.
Il futuro dipende dalla capacità dell’Unione di costruire una visione condivisa.
Dal rischio all’opportunità
Clima, risorse e demografia possono diventare motori di sviluppo se gestiti con politiche efficaci, dialogo internazionale e investimenti verdi. La chiave è trasformare le sfide in opportunità, evitando divisioni e approcci miopi.
L’Europa al bivio: crisi e prospettive di rilancio
L’attuale scenario mondiale è attraversato da forti tensioni geopolitiche, divisioni profonde e nuove vulnerabilità legate a clima, risorse e questioni demografiche. In questo contesto, l’Unione Europea si trova davanti a una svolta: restare ai margini o intraprendere un percorso di rinnovamento strategico.
Debolezze strutturali e potenzialità dell’UE
L’Unione Europea è frenata da processi decisionali e regolatori troppo lenti, che non rispondono con efficacia alla rapidità delle sfide contemporanee.

Fig. 2 - Crescita produttività del lavoro Fonte OECD Economic Surveys: European Union and Euro Area 2025 - july 2025
A queste criticità si aggiungono la mancanza di coesione politica e la crescita stagnante della produttività. Pur disponendo di grandi risorse e competenze, l’UE resta dipendente dagli Stati Uniti per la difesa e fatica a tutelare la propria autonomia geopolitica.
Le difficoltà del mercato europeo, soprattutto nel settore dei servizi digitali e professionali, si riflettono in una produttività inferiore rispetto agli Stati Uniti (Fig.2). Le principali cause sono la frammentazione normativa, la ridotta mobilità lavorativa, la scarsa propensione al rischio nel sistema finanziario e il progressivo calo della popolazione.
Le proposte per il rilancio
Gli analisti (OCSE, BCE, Bankitalia, ecc.) concordano su alcune linee d’azione per superare queste debolezze e rendere l’UE più dinamica:
- Riforma delle istituzioni: completare la revisione dei Trattati, adottare una governance più rappresentativa e un sistema elettorale europeo uniforme.
- Mercato unico più integrato: favorire l’innovazione, la crescita delle imprese e la produttività, riducendo l’onere normativo ed eliminando le barriere interne.
- Maggiore mobilità del lavoro: migliorare il riconoscimento delle qualifiche professionali per facilitare la circolazione dei lavoratori tra i Paesi membri.
- Integrazione del mercato elettrico: ridurre i costi, aumentare le interconnessioni transfrontaliere, diminuire la tassazione e promuovere la concorrenza.
- Investimenti in ricerca e innovazione: aumentare la spesa pubblica per la R&S, valutando rigorosamente i risultati e destinando le risorse ai programmi più efficaci.
- Politiche industriali coordinate: superare l’unilateralità delle scelte nazionali, promuovendo un dialogo continuo tra industria, governi e istituzioni europee. Il coinvolgimento attivo delle aziende è essenziale per definire regole e strategie di lungo termine.

Fig. 3 - Coperture dei fondi di investimento contro il rischio di cambio sul dollaro Fonte Banca d'Italia Finanza e innovazione per il futuro dell'economia
- Sviluppo dei mercati dei capitali: avanzare proposte come la creazione di titoli pubblici europei e di un debito comune, rafforzando il ruolo dell’euro come moneta di riserva e attirando capitali internazionali (Fig.3).
Conclusioni
Dal disordine alla resilienza
L’Europa si trova davanti a un passaggio cruciale della propria storia. Le numerose crisi degli ultimi anni hanno evidenziato vulnerabilità profonde, ma hanno anche messo in risalto la forza di adattamento e la resilienza che il continente è in grado di esprimere. Il compito odierno è quello di evolvere: dalla frammentazione verso una maggiore coesione, dalla lentezza alla visione d’insieme, dall’incertezza a una strategia comune e condivisa.
Il ruolo delle istituzioni e dell’industria
Le istituzioni sono chiamate a predisporre quadri politici e normativi adeguati, ma spetta a manager e imprese essere i veri protagonisti del cambiamento. L’industria, infatti, non rappresenta solo un settore economico, ma costituisce la spina dorsale in grado di sostenere occupazione, promuovere innovazione e garantire stabilità sociale.
Competitività e futuro dell’Europa
Un’industria forte e competitiva permette all’Europa di recuperare il proprio ruolo nello scenario globale. Se guidata da manager visionari e capace di fare sistema, l’Unione Europea può trasformarsi in un laboratorio di crescita sostenibile, centro di eccellenza tecnologica e soggetto politico autorevole. Il futuro della competitività europea si fonderà sulla capacità del tessuto industriale di innovare, investire e collaborare a livello continentale. Le scelte strategiche delle aziende e dei loro leader saranno quindi determinanti per il destino dell’Europa, che si decide tanto nelle istituzioni quanto nel quotidiano delle imprese.
 Localizza
Localizza 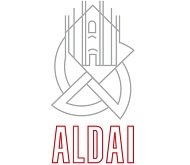




 Stampa
Stampa
 WhatsApp
WhatsApp







