Legge di Bilancio (2026), quali novità e quali timori per i dirigenti?
L’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2026 somiglia molto a quanto avvenne per quella 2025. Il rischio è che si subisca lo stesso trattamento e si finisca per essere ancora una volta la categoria che risolve i problemi di bilancio dell’ultimo governo in carica

Pasquale Ceruzzi
Presidente Commissione Studi e Progetti ALDAI-Federmanager
Si discute molto in questi giorni del disegno di Legge di Bilancio 2026 con la sensazione che i giochi non siano ancora fatti, sebbene non manchi molto alla presentazione ufficiale al Parlamento prevista per il 20 ottobre 2025 con approvazione entro il 31 dicembre.
I protagonisti incontrastati di questa fase sono, come sempre (anzi forse più del solito), il Ministro dell’Economia e delle Finanze da un lato e i partiti (soprattutto quelli governativi) dall’altro. La voracità attuale di quest’ultimi è direttamente proporzionale alle molte scadenze elettorali in arrivo, con votazioni in 7 regioni (Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria). Siamo fortunati ad avere un ministro “navigato” come Giancarlo Giorgetti che dovrà far coesistere tra loro esigenze incompatibili quali i provvedimenti utili ai partiti, le nuove regole della UE, la sostenibilità di bilancio e, naturalmente, le iniziative utili alla crescita economica del Paese.
I partiti della maggioranza hanno già avanzato le loro richieste e queste sono tra loro divergenti. Per Forza Italia le priorità sono il taglio dell’Irpef per il ceto medio con un’aliquota che passerebbe dal 35% al 33% e con una estensione reddituale elevata a 60.000 euro (oggi l’aliquota intermedia ha limite massimo di 50.000 euro). La stima di costo di questo provvedimento risulta di circa 4 miliardi di euro. Poi, al fine di alzare il livello reddituale delle categorie, si richiede di detassare gli straordinari, i premi di produzione e il lavoro festivo. Sono provvedimenti, questi, a doppio taglio perché, pur portando una detassazione in capo al contribuente, richiedono però un numero di ore lavorate più alto non facendo tuttavia aumentare di un solo euro il reddito su base oraria. Inoltre, il provvedimento non è espansivo per quanto riguarda la creazione di nuova occupabilità (non incentiva nuove assunzioni, ma chi è già occupato a lavorare più ore).
La Lega di Salvini punta, invece, da qualche anno, sulle stesse tematiche: agevolare i lavoratori autonomi con priorità come la flat tax estesa a 100.000 euro, una nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali e la possibilità di uscire dal mondo del lavoro a 64 anni usando il TFR.
Questi provvedimenti non trovano il consenso del “ceto medio reale” (quello che supera i 55.000 euro di reddito) e dei dirigenti in servizio e pensionati. Intanto, crea 2 categorie di contribuenti che, a parità di reddito Irpef, sono trattati in maniera diversa (flat tax al 15% per i lavoratori autonomi e aliquote progressive per i dipendenti e i pensionati). I lavoratori autonomi sono trattati meglio rispetto ai dipendenti e ai pensionati.
Queste scelte violano il principio fondamentale dell’equità fiscale e del pari trattamento di fronte alla legge. L’Articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” esclude trattamenti differenziati fra diverse categorie e la proposta presenta evidenti profili di incostituzionalità, ormai ignorati anche dall’opposizione.
Secondo le analisi di Itinerari Previdenziali, nel 2022 i lavoratori dipendenti hanno versato il 52% del totale Irpef, i pensionati ne hanno versato il 30% e i lavoratori autonomi solo il 15%, pur essendo il 21% degli occupati. Il trattamento di favore si accentua ulteriormente considerando l’ennesimo lancio di una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali che costituisce un incentivo all’evasione fiscale e al rinvio dei pagamenti dovuti all’erario. Poi, per il valore reale che portano come recupero di gettito tributario (modesto) non si comprende il beneficio del provvedimento per il Paese.
Perplessità aggiuntive suscita la proposta di uscita anticipata dal mondo del lavoro a 64 anni invece che a 67. In questa maniera si creano scompensi al nostro sistema pensionistico (che non ne ha bisogno) che non potrà contare su entrate contributive importanti in un contesto già complicato di decrescita demografica e di criticità nei bilanci INPS. L’utilizzo del TFR accantonato per sopperire alla mancata contribuzione è insufficiente a ripianare tutti i mancati introiti da contribuzione. Infatti, per redditi netti mensili inferiori a 1.900 euro, la rinuncia al TFR non pareggia l’insufficienza del montante contributivo che si determina verso l’INPS. Inoltre, il provvedimento sembra un incentivo ad andare in pensione invece che rimanere occupabili fino al raggiungimento dell’età pensionistica.
Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) deve far quadrare le entrate di cassa (costituite dal gettito fiscale) con le uscite nel quale confluirebbero anche i costi dei provvedimenti richiesti dai partiti e i costi per lo sviluppo e la crescita del Paese (tema quantomai importante considerando che il PIL del Paese cresce solo dello 0,4% su base annua nonostante i fondi abbondanti già ricevuti tramite il PNRR, sette rate per 140,4 miliardi di euro, pari al 70,2% del piano complessivo).
Qualcuno vorrebbe utilizzare l’extra gettito fiscale che si sta realizzando quest’anno (il “tesoretto” di antica memoria) e il minor costo per interessi che paghiamo sul nostro debito (visto che lo spread del nostro BTP con il Bund a 10 anni si è ridotto intorno agli 80 punti) ma questo non sembra compatibile con gli impegni presi con l’Europa di utilizzare l’extra gettito per ridurre il nostro deficit al 3% entro il 2025.
Anche il tentativo di tassare i cosiddetti extra profitti bancari sembra un’arma già spuntata perché l’ABI (l’Associazione Bancaria Italiana) ha già concordato nel 2024 tre anni di rinvio delle deduzioni fiscali con un beneficio per il bilancio pubblico di 4,3 miliardi di euro nel 2024, 2,5 miliardi nel 2025 e 1,8 miliardi nel 2026.
Qualcuno vorrebbe utilizzare l’extra gettito fiscale che si sta realizzando quest’anno (il “tesoretto” di antica memoria) e il minor costo per interessi che paghiamo sul nostro debito (visto che lo spread del nostro BTP con il Bund a 10 anni si è ridotto intorno agli 80 punti) ma questo non sembra compatibile con gli impegni presi con l’Europa di utilizzare l’extra gettito per ridurre il nostro deficit al 3% entro il 2025.
Anche il tentativo di tassare i cosiddetti extra profitti bancari sembra un’arma già spuntata perché l’ABI (l’Associazione Bancaria Italiana) ha già concordato nel 2024 tre anni di rinvio delle deduzioni fiscali con un beneficio per il bilancio pubblico di 4,3 miliardi di euro nel 2024, 2,5 miliardi nel 2025 e 1,8 miliardi nel 2026.
Al Governo (rappresentato dal MEF) non resta che guardare ad altre poste. Una potrebbe essere quella del concordato preventivo fiscale per gli autonomi che, in una sua prima versione con molte proroghe, porta però solo 3 miliardi di euro e un tasso di adesione intorno al 20%. A questo se ne vorrebbe aggiungere una riedizione, poi, ci sarebbe il maggior gettito da giochi… ma, per saziare gli appetiti dei partiti, le cifre in ballo non sarebbero sufficienti. Si potrebbe anche menzionare un altro provvedimento (ormai “inflazionato”) come la spending review ma sappiamo che quando si parla di taglio della spesa corrente si finisce per fare molto rumore per niente perché questi provvedimenti svuotano i bacini da cui attingono i partiti per costruire le loro promesse elettorali.

All’inizio del 2025, prima del varo della Legge di Bilancio 2025, si era in condizioni simili all’attuale. Richieste elettorali dei partiti diverse tra loro e il ministro dell’Economia e delle Finanze che mediava cercando le risorse per il varo. Alla fine, le trovò tagliando le spese dei ministeri e riducendo le detrazioni d’imposta con ben 2 provvedimenti piuttosto cervellotici. Il primo “erga omnes” legato a determinate fasce di reddito con valore massimo di 1.955 euro di detrazione e valore minimo pari a 0 per redditi sopra i 50.000 euro, il secondo specifico per gli oneri detraibili al 19% con un plafond di 14.000 euro per redditi tra i 75.000 e i 100.000 euro e un plafond di 8.000 euro per redditi sopra i 100.000 euro (il tutto demoltiplicato per coefficienti legati al numero di figli del nucleo familiare; per dettagli vedere articolo di Dirigenti Industria di gennaio 2025: Legge di Bilancio 2025: come le nuove revisioni Irpef incidono sui dirigenti).
È fin troppo palese che le categorie più colpite dalla forbice della Legge di Bilancio 2025 appartengono al “ceto medio reale”, quello con un reddito sopra i 55.000 euro, costituito in buona parte da dirigenti attivi e pensionati. Quel 5,45% di contribuenti che nel 2022 ha versato all’erario italiano 79,8 miliardi di euro, pari al 42% dell’intero gettito Irpef.
Menzione a parte meritano i pensionati perché sono colpiti, dopo l’ennesima rivalutazione ridotta della perequazione delle pensioni, sia per il loro livello di reddito sia per non avere più figli a carico alla loro età (come se questo fosse un elemento di demerito). L’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2026 somiglia molto a quanto avvenne per quella 2025. Il rischio è che si subisca lo stesso trattamento e si finisca per essere ancora una volta la categoria che risolve i problemi di bilancio dell’ultimo governo in carica. Cosa fare allora per scongiurare questo pericolo?
Va bene fare la lista di quanto già dato in passato per finanziare le Leggi di Bilancio, ma forse questa non è una condizione sufficiente. Potrebbe essere utile fare pressione con iniziative mirate ed efficaci sul Governo e sui partiti della maggioranza. Lo scopo dovrebbe essere di ottenere garanzie che questa volta la categoria dei dirigenti non sarà penalizzata, che questa volta se necessario, toccherà ad altri contribuire. A contribuire siano finalmente anche gli evasori e chi si arricchisce senza lavorare.
 Localizza
Localizza 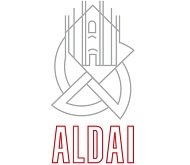




 Stampa
Stampa
 WhatsApp
WhatsApp







