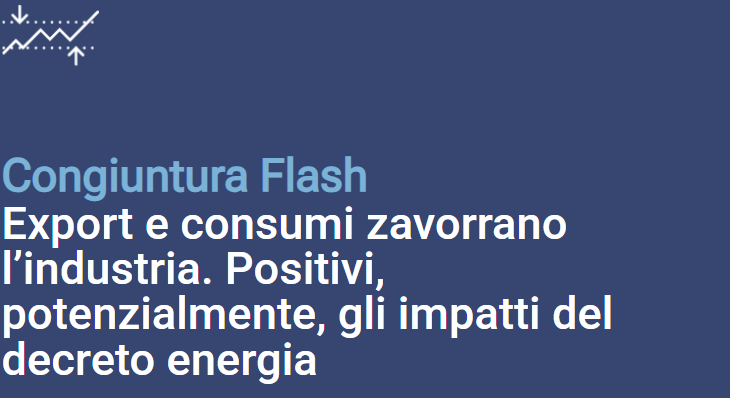Caravaggio ultimo atto
Questo è un articolo su una bellissima mostra tenuta a Napoli, ottobre 2004 - gennaio 2005, sull’ultimo periodo di Caravaggio. Spero che la prossima mostra Dentro Caravaggio, qui a Milano dal 29 settembre 2017 al 28 gennaio 2018, mi dia la stessa gioia..

Giuseppe Firrao
Componente GdL Cultura ALDAISì, lo so: il nome esatto della mostra napoletana è Caravaggio. L’ultimo tempo 1606-1610 ma, questo titolo mi è uscito di getto, quasi che la vita di Caravaggio sia stata teatro e che questi ultimi quattro anni non fossero altro che la prefigurazione della calata di un sipario, lì sulla spiaggia di Port’Ercole, nel torrido luglio del 1610.
* * *
Ero uscito profondamente deluso da una mostra a Mantova, Le ceneri azzurre di Giorgione, mostra curata da un guru mediatico e mediaticamente pompata sui giornali. Deluso dalla organizzazione, deluso dalla mostra in sé, troppi quadri affastellati, artisti noti ed altri meno, quasi che da questa esposizione se ne volessero far nascere altre di approfondimento di artisti che fanno parte della collezione privata del sopra lodato guru.
Deluso, infine, dal muro rosso e nudo, con cui si chiudeva la mostra mantovana. Lì avrebbe dovuto esserci il Caravaggio romano, la caduta di Saulo da cavallo, considerato l’ultimo capolavoro del manierismo ed il primo di una nuova maniera, quella del ritorno alla rappresentazione del vero. Purtroppo, dispute ministeriali avevano permesso solo ai visitatori della prima settimana di ammirare il quadro, che, subito dopo, aveva ripreso la via di Roma, lasciando la parete vuota e nemmeno inquietante.
Fu mia moglie Adriana a suggerirmi una via di riconciliazione col mondo delle mostre.
A Napoli si apriva, l’ultima settimana di ottobre (2004), la mostra dell’incipit e noi avevamo in programma di passare il lungo ponte dei Santi nel nostro buen retiro del sud del Lazio. Quale migliore occasione?
Anche se di sabato, Napoli ci accolse col caos frenetico del traffico di chi andava o tornava dai cimiteri, la stessa frenesia con cui Caravaggio, spirito più agitato che non il mare di Messina con le sue precipitose correnti, aveva bruciato la sua vita e specie gli ultimi quattro tumultuosi anni, correndo dalla campagna a sud di Roma a Napoli e di qui a Malta, da Malta alla Sicilia di Siracusa, Messina, Palermo, luoghi che, come dice il curatore della mostra, Nicola Spinelli, “trasformarono completamente il suo modo di fare arte, il suo punto di vista rispetto allo spazio, alla luce, all’essere e all’esistere dell’uomo”. Ma non riuscì a fermarsi più che tanto in Sicilia ed allora, come una falena attirata dalla luce di Roma di nuovo su, ancora a Napoli e poi, febbricitante, su di una feluca, ancora su, lungo la costa campana e laziale fino a quel buco del mondo che allora doveva essere la spiaggia di Port’Ercole, lì, dove sperava sempre nella perdonanza del Papa, lì, dove la vita lo lasciò, definitivamente.
Quattro anni tumultuosi come questo traffico impazzito di questa bella città, in cui solo il genio del tassista riesce a districarsi, così come solo il genio pittorico riuscì ad evitare che Caravaggio si perdesse ben prima che l’ultimo atto facesse il suo corso.
Estate del 1606. Caravaggio ha appena ucciso un suo compagno di strada in una lite di gioco, (la pallacorda: ora non si muore più sugli spalti dei campi da tennis, ma su quelli del calcio, sì) ed è stato costretto a rifugiarsi prima nel Basso Lazio e poi a Napoli. E Napoli lo accolse, così come ora ci accoglie il parco di Capodimonte, e, così come noi ora ci immergiamo nell’abbraccio di una salda organizzazione, così lui si immerse nella vita dei vicoli, studiò, osservò, e ci donò il primo capolavoro del soggiorno partenopeo, Le opere della misericordia, dove “cambia il concetto di spazio che si dilata sempre di più ma che non è misurabile in termini reali, geometricamente o prospetticamente definibile, perché la misura è data dall’uomo e dal tempo dell’azione dell’uomo, dal gesto”.
Il gesto.
In basso a destra quello della donna che “dà da mangiare all’affamato e da bere all’assetato” offrendo il suo seno ad un vecchio, così, con naturalezza, mentre il suo occhio corre verso il centro della scena. Sì, lo so si tratta di un tema caro alla cultura barocca, il vecchio Cimone nutrito in carcere dalla figlia Pero, Mattia Preti ne ha fatto un quadro, che mi ha dato sempre una vaga sensazione d’incesto, che qui non c’é. Il vecchio è un poveraccio, la donna è una popolana del vicolo, dove s’intrecciano vita e morte, rappresentata da due piedi, memoria della scandalosa Dormitio Virginis, sostenuti da colui che “seppellisce i morti”.
Il gesto. Quello del bellissimo giovane al centro, che sta per “vestire l’ignudo”.
Il gesto dell’angelo che protende dall’alto una mano, quella mano che, col suo rossore come di uno che l’abbia a lungo premuta su di un tavolo, ci dà l’evidenza di come Caravaggio ancora nel primo soggiorno napoletano dipingesse dal vivo.
Il gesto, infine, della Madonna (della seggiola senza seggiola) e del bambino, che si protendono come da un palchetto costituito dalle ali dei due angeli che in cielo ballano la voltarella. Ali, ali vere, come eravamo abituati a vedere nel cigno che seduce Leda e non le alucce, cui il manierismo deteriore le aveva ridotte.
E dopo il gesto la vita del vicolo, vita vera, vita anche cruda, che gli rimane nella memoria, e gli fa trasformare, un anno dopo, a Malta, in Amorino dormiente un bambino forse morto, la pancina gonfia, le manine deformate dall’artrosi reumatica, cui la sola aggiunta iconografica delle frecce richiama al titolo del quadro.
Vita da vicolo, vita da taverna, quella in cui è ambientata La Cena in Emmaus (che qualche critico pensa dipinta nel Basso Lazio). È sparita la canestra di frutta (memoria ambrosiana), che Caravaggio dipinse nella precedente Cena in Emmaus, anch’essa in mostra a sottolinearne le differenze, sostituita da una brocca, più appropriata al luogo; sostituito il gesto di riconoscimento, un po’ teatrale, di uno dei discepoli, con uno più contenuto: solo la mano che stringe il bordo del tavolo ci rende la tensione del momento; aggiunta in alto a destra una vecchia, le rughe sottolineate dal raggio di luce, carne che si avvia a disfarsi; sostituito, infine, il primo Cristo paffutello (mi ricordava sempre il Bacco dell’Ambrosiana; forse era lo stesso modello) con uno più emaciato, più compreso del gesto della consacrazione, col dito teso che ci invita ad entrare nel quadro.
E, poi, le possibili origini. La Flagellazione del Merisi è accostata a quella del Tiziano; la conobbe, vi s’ispirò? Lasciamo ai veri critici d’arte la dotta disquisizione. Io penso che, se la conobbe, l’adattò al tempo dell’azione (pittorica) dell’uomo Caravaggio a Napoli. L’Uomo-Dio muscoloso del maestro veneto, senza una goccia di sangue, la corona di spine che si trasforma in aureola, gli occhi rivolti al cielo, qui torna ad essere solo l’uomo, contorto in modo quasi manieristico, gli occhi chiusi o che guardano a terra, la corona ben visibile: è di spine, ben confitta in testa ed il sangue comincia a sgorgare
Ma è ormai tempo di andare. È passato meno di un anno, un periodo fecondo per il pittore e rivoluzionario per tutta la pittura napoletana, segnando il percorso di artisti quali Caracciolo e il Ribera, ed è difficile comprendere perché l’artista lombardo sentì l’improvviso bisogno di andare da Napoli a Malta, isola geograficamente piccola ma grande dal punto di vista religioso, essendo, a quei tempi avamposto militare cattolico affidato ai cavalieri dell’Ordine di San Giovanni.
Si può pensare che due motivi abbiano contribuito alla decisione, da una parte il desiderio del Gran Maestro in carica, Alof de Wignacourt, di avere un pittore al proprio servizio e dall’altro la speranza del Caravaggio in un cavalierato che lo avrebbe politicamente avvicinato a Roma ed al perdono papale.
Svanita la possibilità di avere a Capodimonte il celeberrimo Decollazione di San Giovanni Battista (del periodo maltese c’è solo un Ritratto di Cavaliere Gerosolimitano, dalla sottile introspezione psicologica) a causa delle sue enormi dimensioni (11 metri di base), c’è, però la possibilità di vederne una riproduzione mediatica. Da essa si può apprezzare quanto il dipinto abbia guadagnato dal recente restauro fiorentino; qui si vede come Caravaggio sia riuscito a bilanciare con rigore e fermezza gli estremi di passione e crudeltà del lato sinistro della scena con il mondo esterno rappresentato dalle due figure che si affacciano dall’inferriata della parte destra (che in alcune riproduzioni precedenti, anche recenti, non ero mai riuscito a vedere così distintamente). Essi (due prigionieri?) guardano con quieta tristezza la scena, che è un teatro di vuoti, dislocazioni ed azioni bloccate nel cortile di un’austera prigione, dalla geometria inflessibile, dalle pareti di pietra fredde ed inospitali.
Teatro. Ed, infatti, come se il Merisi fosse un personaggio in cerca di autore, la cui vita è stata già disegnata nel momento della sua creazione, ecco arrivare nell’agosto del 1608 un oscuro episodio di cui non si sono mai conosciuti i particolari (una rissa?), in seguito al quale c’è l’imprigionamento, la fuga avventurosa dal carcere e, infine, l’approdo a Siracusa.
Si trattiene in Sicilia per un anno, lasciando a Siracusa, Messina e Palermo tele in cui ormai il buio dilaga. A Capodimonte ne possiamo ammirare tre, il Seppellimento di santa Lucia, la Resurrezione di Lazzaro e l’Adorazione dei pastori dove “il buio inghiotte gran parte della scena e l’azione si condensa in un unico, intensissimo attimo, bloccata come in un fotogramma, dove volti, corpi, espressioni sono colti di sorpresa da sciabolate di luce battente”. Comincia a ritrovarsi nelle prime due tele il presagio della fine, laddove le sciabolate di luce colpiscono qui il corpo della santa steso a terra, là quello di Lazzaro sostenuto da un samaritano. Il gossip della critica a lui contemporanea, che ha colpito il Caravaggio più di qualsiasi altro artista maledetto, ci riporta che il corpo del resuscitato fosse quello di un cadavere, a cui si poteva ben attagliare la frase della sorella di Lazzaro, jam fetet, ma l’impressione è che ormai il maestro dipingesse non più dal vero ma richiamando dalla memoria figure e gesti già dipinti.
Un paio di anni fa vedemmo ad Alba una mostrina di un pittore a noi sconosciuto, Macrino, che ebbe la ventura di essere portato da un vescovo locale a Roma per un quinquennio, a metà del cinquecento. Lo splendore dell’arte dei grandi maestri romani colpì l’albese come una folgore e gli regalò un periodo di fulgore, che lentamente svanì al suo ritorno in Piemonte: la sua pittura ricopiò se stessa e gli stilemi del periodo glorioso.
Non è lo stesso per il Caravaggio. Anche se ritroviamo gesti già visti (il braccio del Cristo nella Resurrezione di Lazzaro è lo stesso della Conversione di San Matteo) questi sono rivisitati ed inseriti nella nuova temperie che la fantasia gli andava suggerendo. Non solo il linguaggio diventa più scarnificato ma il Merisi comincia ad inserire non dei pentimenti ma, addirittura, delle nuove figure, non previste inizialmente, come la vecchia inginocchiata sulla destra del corpo di Santa Lucia, il viso dipinto a rapidi tratti, quasi impressionistici, ma non le mani, che, portate sulle guance (ancora una memoria: quella della vecchia della Decollazione), ci esprimono da sole il dolore del mondo; si può ripetere anche per il periodo siciliano quello che qualcuno ha scritto della maltese Decollazione di San Giovanni Battista: “è facile uccidere un uomo ma il mondo resterà fuori asse per sempre”.
Ma via, via anche dalla Sicilia. Roma chiama, il desiderio del perdono del Papa urge l’artista che si avvicina alla città agognata tornando a Napoli.
È l’autunno del 1609.
Si disse di lui che i suoi costumi sono simiglianti ai suoi lavori, e così anche la sua fisionomia e aspetto.
E la sua fisionomia e aspetto li ritroviamo nella testa di Golia sostenuta da David; è lui, il Caravaggio, la bocca ancora aperta nell’ultimo grido, l’occhio destro che si appanna ma il sinistro ancora vivo. Il presagio di morte, quello della sua propria morte ormai gli incombe addosso, ma il maestro si regala almeno uno che lo compianga. Nello sguardo di David, l’ultimo di una stirpe di quei ragazzi da lui tanto amati, io leggo un’infinita sofferenza, un sofferto addio; anche David è un personaggio che nel Caravaggio ha trovato il suo autore: ha dovuto ucciderlo ma lo piange.
L’ultimo atto è agli sgoccioli, già i serventi stanno per sciogliere il sipario, la feluca gonfia le vele, vi s’imbarca con una Maddalena e due San Giovanni Battista, forse quelli in mostra qui a Capodimonte, ma non sono più il fanciullo radioso dell’Amore vittorioso, sono emaciati, la pelle che si arrotola sul ventre: i suoi lavori sono simiglianti al suo aspetto, a come lui ora si vede, la sola speranza nella perdonanza a sostenerlo.
Aspettate, servi di scena, tendete ancora le corde. La feluca deve ancor risalire la costa, deve passare al largo di Roma, giungere al litorale malarico di Port’Ercole.
È il 27 luglio del 1610.
Giù il sipario, giù.
Caravaggio.
Ultimo atto.
 Localizza
Localizza 




 Stampa
Stampa
 WhatsApp
WhatsApp