Il peso della sentenza 19/2025 della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale si era riunita lo scorso 29 gennaio: riunitosi con solo 11 componenti, dopo aver sentito le dichiarazioni in merito dei vari avvocati aveva chiuso il dibattimento per deliberare in merito.

Franco Torelli Presidente Federmanager Trento - Neo componente del Comitato Nazionale Pensionati
La Corte Costituzionale si era riunita lo scorso 29 gennaio per deliberare sui ricorsi inviati dalla Corte dei Conti di Toscana e Campania per la questione sollevata di legittimità Costituzionale sui tagli della perequazione pensionistica della Legge di Bilancio 197/2022 relativi al 2023 e 2024. La Consulta, riunitosi con solo 11 componenti, dopo aver sentito le dichiarazioni in merito dei vari avvocati aveva chiuso il dibattimento per deliberare in merito.
La Corte Costituzionale, detta Consulta per via della sua sede nel palazzo della Consulta a Roma, lavorava a ranghi ridotti con 11 dei 15 componenti previsti perché 4 avevano terminato il loro mandato di nove anni e la Costituzione prevede un delicato equilibrio nell’assortimento dei componenti: cinque vengono eletti dai magistrati di ciascuna delle tre magistrature superiori (tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato, uno dalla Corte dei conti) e sono portatori di qualificate esperienze giudiziarie e sganciati dalle scelte degli organi politici; cinque sono scelti dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa e gli ultimi cinque sono eletti dal Parlamento in “seduta comune”, cioè dalle due Camere riunite.
Questi giudici di nomina parlamentare sono scelti per lo più tra professori, avvocati e magistrati e possono più facilmente essere portatori di esperienze e di sensibilità presenti nel mondo della politica e spesso hanno anche alle spalle un’attività parlamentare.
Il 13 febbraio i parlamentari di Camera e Senato si sono accordati e dopo ben 14 tentativi hanno eletto i 4 giudici mancanti: due giudici designati dai partiti che sostengono il governo, uno dalle opposizioni e uno “indipendente”, ossia condiviso dalla maggioranza degli schieramenti.
E già il 14 febbraio la Consulta con la sentenza 19/2025 giudica non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle due sezioni regionali della Corte dei Conti di Toscana e Campania, per cui la legge di bilancio 2023, nell’introdurre misure di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni “non ha leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamenti pensionistici”.
La Corte non è una terza istanza legislativa, a cui si possa fare ricorso per contestare o modificare, con una valutazione politica di opportunità, le scelte fatte dai rappresentanti eletti in Parlamento: essa sta a guardia dei confini – ampi – della Costituzione e non ha alcun potere di censurarne le valutazioni parlamentari, anche se magari le appaiano inadeguate o difettose.
C’era quindi da aspettarsi un esito di questo genere dovendo cioè decidere in merito a questioni impattanti sul bilancio dello Stato?
Probabilmente si: la Consulta è diventata da tempo un Organismo politico-partitico, con membri spesso schierati, non riesce più ad essere un Organismo “terzo” equidistante tra chi fa le leggi e chi le applica e tende invece a privilegiare la parte di chi governa, di qualsiasi colore essa sia.
È una modesta consolazione che la Corte riconosca che questi tagli sono in effetti “l’ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo” e che auspichi che il legislatore ne tenga conto “per eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici” oppure che auspichi una “disciplina più stabile e rigorosa” del meccanismo di perequazione.
Ormai è giunto il momento, come sostiene il nostro Presidente federale nella sua lettera “Per una giustizia fiscale e previdenziale”, di impegnarci in una campagna di mobilitazione per far valere i nostri diritti e far sentire la nostra voce meno timidamente che in passato.
A breve verrà avviata l’impostazione della Legge di Bilancio 2026 e sarà l’occasione per farci sentire attraverso azioni forti da discutere e condividere al prossimo Consiglio Nazionale del 28 marzo: visti i risultati deludenti sul piano Giudiziario occorre indirizzare la nostra azione sul piano politico ponendoci come obiettivo per lo meno la conferma del modello di rivalutazione per scaglioni che ha avuto applicazione quest’anno anche grazie alle battaglie di Federmanager e CIDA.
Troppi politici si sono riempiti la bocca con richiami alle esigenze del Ceto Medio, senza però tradurre le parole in atti concreti. Ora basta.
16 aprile 2025
 Localizza
Localizza 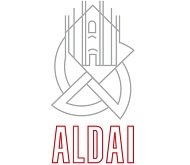




 Stampa
Stampa
 WhatsApp
WhatsApp
