Quelli che erano stati presentati come provvedimenti temporanei si sono trasformati, con il passare del tempo, in regole stabili. E il risultato è sotto gli occhi di tutti: anno dopo anno il potere d’acquisto dei pensionati del ceto medio è stato progressivamente eroso. Il grafico – nell’articolo - lo racconta con chiarezza: un cantiere sempre aperto, dove ogni governo ha lasciato la sua impronta fatta di tagli, blocchi e riduzioni.
Nel frattempo, sono in corso i lavori per preparare la prossima Legge di Bilancio, quella del 2026. Non sappiamo quali sorprese saranno riservate ai pensionati; ciò che invece conosciamo bene è quello che è accaduto negli anni passati. E non si tratta di un episodio isolato, ma di una storia che si ripete da troppo tempo.
Per questo i pensionati non possono più limitarsi ad assistere, come spettatori, ai lavori di questo interminabile “cantiere”. È il momento di assumersi responsabilità collettive: unirsi, stringere alleanze, partecipare alle iniziative di tutela che saranno messe in campo. Perché i diritti non sono mai acquisiti una volta per tutte: resistono solo se vengono difesi, giorno dopo giorno
(1) Contributo di solidarietà del 15% applicato sulla quota eccedente 1,5 milioni di euro, riferita a TFR, TFS o trattamenti integrativi.
(2) Contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nelle Inps (ex Fondi Volo, Telefonici, Elettrici, Ferrovieri, Ferrotranvieri, Inpdai).
(3) Il meccanismo di perequazione è totalmente modificato: la perequazione non è più calcolata con i sistema a “scaglioni” ma con quello a “fasce”. Con il primo sistema una pensione è rivalutata in base alle diverse aliquote attinenti ai vari scaglioni in cui essa ricade, con il secondo una pensione è rivaluta con la sola aliquota corrispondente alla fascia o classe in cui si trova.
(4) Contributo di solidarietà su pensioni medio alte disposto per 5 anni. Periodo di applicazione ridotto a 3 anni a seguito della Sent. Cost. n.234/2020.
(5) La disposizione è diretta a limitare l’effetto della perequazione sugli importi pensionistici dei pensionati residenti all’estero con reddito pensionistico superiore all’importo minimo.
Il cantiere delle pensioni
Il grafico sopra racconta, meglio delle parole, a colpo d’occhio, la storia dei tagli che hanno colpito le pensioni. Esponiamo qualche dettaglio solo per consentire una più rapida lettura di quello che è accaduto ai pensionati nei primi 25 anni di questo secolo.
- 15 anni complessivi di riduzione mediante 5 c.d. “contributi di solidarietà”, distribuiti a intervalli quasi regolari dal 2000 al 2021, ciascuno della durata di 3 anni. A questi si sono aggiunti altri due prelievi straordinari, rispettivamente di 3 e 6 anni, su prestazioni particolari e pensionati provenienti da enti soppressi (c'è anche una lunga storia di prelievi cominciata il secolo scorso: v. box in calce al testo).
- 14 anni complessivi - di cui 13 in 17 anni, tra il 2008 e il 2025 - sono segnati da interventi sul meccanismo di perequazione automatica (blocchi o riduzioni delle aliquote di rivalutazione) durante i quali il potere d’acquisto dei pensionati è stato sistematicamente eroso. Per sintesi: fino al 2024, sono stati applicati sette (7) interventi per ridurre il potere d’acquisto delle pensioni medio-alte; l’ottavo (8) è tuttora in corso (2025) ed è “riservato” ai soli pensionati residenti all’estero con trattamenti superiori al minimo INPS: sono circa 60mila pensionati sparsi in 160 Paesi del mondo, che proprio a causa di questa dispersione hanno perfino difficoltà a tutelare i loro diritti.
Riassumiamo: negli anni si sono susseguiti interventi che hanno ridotto il potere d’acquisto delle pensioni, sovrapponendosi più volte ai prelievi straordinari che non vengono qualificati come imposte ma che, secondo la Corte di Conti, pur formalmente fuori dal perimetro dell’Irpef, «operano come l’Irpef e con questa s’intrecciano»1
Il risparmio sui pensionati
Dalla documentazione tecnica che accompagna le disposizioni emesse, nell’ arco di tempo di cui parliamo, sulla sospensione o sul peggioramento del meccanismo di rivalutazione automatica, emerge un dato eloquente: fino al 2034 la spesa pensionistica viene ridotta di circa 88 miliardi di euro. Un risparmio per lo Stato, certo, in pratica, però, è come tre manovre finanziarie (circa) scaricate sulle spalle dei pensionati.
Lo abbiamo già detto in un nostro precedente articolo2, e vale la pena ripeterlo: questa non è che la rappresentazione contabile dei risparmi previsti. La realtà concreta si misura invece negli effetti che tali provvedimenti producono sui redditi dei pensionati. Infatti, una volta terminato il periodo di applicazione delle norme restrittive sulla perequazione, il meccanismo di adeguamento delle pensioni all’inflazione riprende a funzionare. Tuttavia, la pensione non viene ricalcolata a partire dall’importo originario, ma dall’importo ridotto, conseguenza del mancato o parziale adeguamento intervenuto nel frattempo. Questo significa che la perdita subita non viene mai più recuperata: l’erosione del trattamento pensionistico si consolida e continua a produrre i suoi effetti nel tempo, per tutta la vita del pensionato. L’effetto di riduzione permanente diventa ancora più grave quando tali misure vengono reiterate a breve distanza l’una dall’altra: in questo caso la falcidia del potere d’acquisto procede inesorabilmente, con progressione crescente.
Le criticità
Il quadro che abbiamo descritto vuole fornire spunti di riflessioni su quello che a noi appare un aspetto rilevante sul numero e, soprattutto, sulla lunghezza temporale dei provvedimenti che hanno colpito le pensioni. Oltre ai contributi solidaristici, sono gli interventi sul meccanismo di perequazione quelli che, soprattutto, hanno devastato e devastano le pensioni. Prendere posizione, su questo fronte, è diventato più che necessario, urgente. Occorrono prese di posizioni chiare e ben definite. Non è facile. Perché a partire dalla seconda metà degli anni ’80, la Corte Costituzionale ha continuato a fornire il proprio contributo volto a invertire le spinte espansionistiche insite nel sistema pensionistico.3 Nel contempo, però, ha anche richiamato la politica a tener conto delle conseguenze dei provvedimenti adottati che continuano a gravare sulla pelle dei pensionati. La politica, per parte sua, ha fatto, come si dice, orecchie da marcante: non solo non è riuscita a varare “una riforma previdenziale vera, che sappia guardare al futuro con coraggio e responsabilità, che riconosca e valorizzi tutto il lavoro, quello degli attivi e quello di chi nel lavoro ha già dato”, come ha detto il Presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento Gruppi Seniores di Federmanager, Mino Schianchi4, ma non è stata neppure in grado di stabilizzare il meccanismo di indicizzazione. Ha continuato, invece, nel corso degli anni, con “modifiche ed andamenti a stop and go”.5 Il ripetersi nel tempo e la mancanza di recuperi hanno finito per trasformare interventi temporanei in regole strutturali. Ciò che avrebbe dovuto essere un sacrificio momentaneo è diventato, nella sequenza dei Governi che si sono succeduti in questi 25 anni, un sistema ordinario di compressione della perequazione. Non tenendo in nessun conto dei richiami della Corte Costituzionale. Moniti dettati anch’essi fin dagli anni’80. Richiami al legislatore per un giusto equilibrio fra spesa pensionistica e diritti soggettivi dei pensionati, con specifico riferimento al limite temporale dei provvedimenti che incidono sulle pensioni. La Corte ha continuato a ripetere che «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità»6. Nelle sentenze più recenti, il monito punta soprattutto all’effetto di “trascinamento” che, nel tempo, “rende sostanzialmente definitiva anche una perdita temporanea del potere di acquisto” (Sent.n.234/2020). Ancora più rilevante il richiamo contenuto nella sentenza n.19/2025. Questa, pur avendo respinto i ricorsi contro la legge n. 197/2022, art. 1, comma 309, deludendo così i pensionati che speravano, questa volta, in un cambio di passo, non ha mancato, tuttavia, di mettere in evidenza un punto cruciale di tutta la questione. Ha osservato che quella norma, per come è congegnata, pur rispettosa dei parametri di rivalutazione della pensione “costituisce l’ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo”. Una considerazione fondamentale, da non leggere come una semplice formula descrittiva; al contrario, perché la stessa sentenza fa riferimento7 al meccanismo di rivalutazione standard (art.34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) come “regola che, in ossequio alla durata indeterminata espressamente conferitale, dovrebbe essere interessata con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi”. Siamo davanti alla prova che le sospensioni e le alterazioni della perequazione non sono più episodi contingenti, ma elementi ormai radicati della disciplina pensionistica, in netto contrasto con i principi fondamentali di adeguatezza, proporzionalità e temporalità di provvedimenti che incidono sulle pensioni. A sostegno di questa linea riteniamo fornisca un contributo notevole anche l’altra recente decisione della Corte Costituzionale (Sentenza n. 135/2025), quando sostiene che di fronte a situazioni eccezionali di crisi finanziaria, possano essere introdotte misure straordinarie che riducono alcune prestazioni economiche. Ma quando questi interventi, nati come emergenziali, vengono reiterati o trasformati in regole permanenti, allora, in questo caso, il carattere straordinario svanisce e il provvedimento diventa una compressione stabile e sproporzionata di diritti costituzionalmente garantiti.
Conclusione
I giuristi avranno modo di esporre le loro valutazioni: se la continuità con cui, negli anni, è stato compresso il meccanismo di rivalutazione delle pensioni abbia finito per alterare la natura stessa delle norme che lo regolano. Sarà loro compito chiarire se la lunga sequenza di interventi – sempre a carico degli stessi soggetti e con effetti progressivamente più gravosi – abbia oltrepassato i limiti più volte richiamati dalla Corte Costituzionale.
Noi pensionati, però, abbiamo una responsabilità precisa: partecipare attivamente all’elaborazione delle proposte di tutela e di miglioramento delle pensioni che i nostri organi di rappresentanza vorranno presentare. I nodi sul tavolo sono chiari: una pressione fiscale che continua a colpire soprattutto il ceto medio e, al suo interno, in misura maggiore i pensionati; una riforma previdenziale che rimane irrisolta; la difesa del potere d’acquisto delle pensioni, tema centrale su cui ci siamo soffermati in questo articolo.
Sono questioni sulle quali dobbiamo esercitare il nostro diritto-dovere di informarci, discutere e partecipare alle decisioni che vengono adottate. Diversamente, i nostri interventi, commenti e critiche non sono altro che “prediche inutili”, per riprendere le parole e l’insegnamento di Luigi Einaudi.8
1 Cfr. Corte dei Conti Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica
2V. in questa Rivista, agosto 2025, Deindicizzazione delle pensioni: da strumento eccezionale a misura permanente
3 Camera dei Deputati, Documentazione parlamentare, focus 5 luglio 2022, Politiche per il lavoro e previdenziali, Giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale.
4 V. in questa Rivista, agosto 2025, Mino Schianchi, Pensioni e finanza pubblica: un equilibrio (in)giusto
5Cfr. Corte dei Conti Sez. Riunite. Audizione sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 […]
6 V. Corte Costituzionale Sent. n. 349/1985, n. 372/1998, n.316/2010, altre. Monito ripetuto da decenni, mai tenuto in conto dal legislatore.
7 Il richiamo contenuto nella sentenza rinvia all’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019.
8 Cfr. Luigi Einaudi, Prediche inutili – Dispensa Prima, p.6: Conoscere per deliberare, Ed. Einaudi, 1955.


 Localizza
Localizza 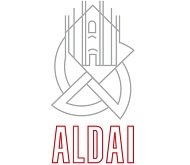




 Stampa
Stampa
 WhatsApp
WhatsApp










