Ripensare il rapporto tra individuo e denaro
Il denaro è buono o cattivo?

Francesco Baroni
Coordinatore del Circolo di Filosofia*
Esiste nella nostra tradizione una schizofrenica contraddizione rispetto al denaro: da una parte la maggior parte degli individui e delle organizzazioni desiderano più denaro possibile, e lo ricercano con grande passione nella loro vita quotidiana, ma dall’altra la maggior parte delle persone, interrogate sul denaro, lo disprezzano pubblicamente, considerandolo “sterco del diavolo”, “ciò che non fa la felicità”, motivo di corruzione dell’interiorità, qualcosa da avere giusto il minimo indispensabile. Come è possibile che entrambi queste correnti di pensiero, uno implicito e uno esplicito, stiano assieme?
Le persone notano gli aspetti positivi del denaro, cioè il suo uso nel procurarsi dei mezzi materiali che ci permettono di risolvere alcuni problemi, e anche gli aspetti negativi, cioè il suo potere, per cui ci si può procurare dei mezzi per fare del male, per sprecare risorse, per esercitare la propria influenza sugli altri contro il loro interesse. Privatamente, ricerchiamo il denaro per i suoi aspetti positivi; pubblicamente, lo denigriamo per il secondo motivo.
Tuttavia non c’è una così chiara demarcazione: anche privatamente si può usare il denaro per fare del male, e pubblicamente si può utilizzare per fare del bene, per cui questo modo di comunicare getta il senso comune in uno stato di confusione, proiettando sul denaro l’ombra del senso di colpa.
Indubbiamente c’è qualcosa di saggio in una tradizione di migliaia di anni sull’uso del denaro, ma evidentemente c’è qualche problema in essa, se si arriva a questa schizofrenia dolorosa. Serve dunque un criterio, cioè una bussola che ci aiuti a capire quando il denaro è da amare o da disprezzare.
Per farlo, bisogna rispondere alla domanda: “il denaro è buono o cattivo”? La risposta fu data già da Aristotele: il denaro non è un fine, è solo un mezzo per procurarsi degli altri oggetti, e come tale va trattato; non può essere desiderato o disprezzato in sé, ma solo in base ai fini che con esso si perseguono. In altre parole, usando le parole di Seneca, il denaro è un indifferente, cioè né un bene né un male, ma qualcosa che può essere usato per ottenere il bene o il male.
La domanda che segue allora è: quali sono i fini buoni o cattivi che con il denaro si possono perseguire? Domanda complessa, a cui le varie tradizioni hanno dato risposte diverse. La risposta più convincente è questa: nell’uso del denaro, colui che lo usa deve ben ponderare quanta felicità può procurargli, e cercare di massimizzarla il più possibile, riducendo nello stesso tempo la propria sofferenza.
Finiamo dunque in un bieco egoismo? Importa solo la felicità individuale? Il miglior egoismo è anche altruismo: ogni individuo è parte di un organismo, cioè la società a cui appartiene, che in senso lato non è solo il proprio Paese, ma anche l’umanità intera. Se l’individuo danneggia questo organismo, questo soffre, e quindi, alla fine, provoca dolore e danno anche a sé stesso. Se l’individuo vuole essere felice, deve quindi spendere il denaro anche nella cura della società di cui fa parte.
*Il Circolo di Filosofia è un’associazione che ama riflettere su queste e altre tematiche filosofiche. Teniamo delle lezioni serali in videoconferenza, e ci avvaliamo di autorevoli professori universitari. La nostra missione è insegnare la filosofia in modo accessibile a tutti coloro che sono interessati, anche se partono da zero
SAVE THE DATE
L'incontro dedicato al Rapporto tra individue e denaro si terrà
mercoledì 20 novembre 2024 alle ore 17:30
presso la Sala Viscontea Sergio Zeme
Per partecipare è necessaria la registrazione su www.aldai.it
01 novembre 2024
 Localizza
Localizza 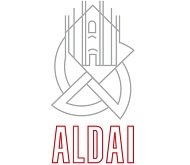




 Stampa
Stampa
 WhatsApp
WhatsApp







