Crisi demografica, implicazioni su sistema pensionistico e politiche di welfare
L’Italia affronta un inverno demografico che minaccia la tenuta del welfare e delle pensioni: meno nascite, più anziani, giovani in fuga e lavoro instabile. A pagare il prezzo sono i pensionati e il ceto medio, colpiti da misure depressive e da una politica assente. Per invertire la rotta servono riforme fiscali e previdenziali coraggiose, politiche per l’occupazione e la natalità, e un impegno concreto per restituire equità e dignità sociale a chi ha sempre contribuito allo sviluppo economico e sociale del Paese

Mino Schianchi
Presidente Comitato Nazionale di Coordinamento Gruppi Seniores Federmanager e Presidente Comitato Pensionati ALDAI-Federmanager
Il quadro dell’inverno demografico
Negli ultimi 40 anni, la demografia italiana ha subito una trasformazione radicale: il “boom” demografico degli anni '60-70 ha lasciato spazio, via via, a una progressiva e inesorabile diminuzione delle nascite, a un invecchiamento accelerato della popolazione e a una crescente importanza delle dinamiche migratorie come fattore di equilibrio socioeconomico. Questa trasformazione non è semplicemente una questione sociale, ma una sfida strutturale che mette in discussione i fondamenti stessi del modello di welfare e del patto intergenerazionale su cui il Paese ha prosperato nel dopoguerra. Questa trasformazione sta coinvolgendo tutte le dimensioni del Paese: dalla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e sanitario all’organizzazione del welfare, dal mercato del lavoro alla coesione sociale.
Secondo l’Istat, con l’attuale inverno demografico, la popolazione italiana dovrebbe passare dai circa 59 milioni al 1° gennaio 2023 a 58,6 milioni nel 2030 e a 54,8 milioni nel 2050. Il dato più significativo di questa tendenza è il tasso di fecondità, che nel 2024 è sceso a un nuovo minimo storico di 1,18 figli per donna. Questo valore è drammaticamente lontano dalla soglia di sostituzione generazionale di 2,1 figli per donna, necessaria per mantenere stabile la popolazione in assenza di migrazioni.
Fattori economici, sociali e culturali del calo demografico
Uno degli ostacoli principali alla natalità in Italia è rappresentato dai fattori economici: il costo della vita, la precarietà e la bassa retribuzione lavorativa, l’accesso difficile alla casa e ai servizi pubblici per l’infanzia rendono ardua la decisione di mettere al mondo figli.
Accanto ai motivi economici si sommano fattori culturali: l’aumento dell’età media al primo figlio (oggi oltre 32 anni), il posticipo delle scelte familiari, un’incertezza diffusa riguardo il futuro e una nuova concezione dell’autorealizzazione che non coincide più - o non solo - con la genitorialità. La trasformazione del ruolo femminile, pur avendo portato a una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro, non si è accompagnata a un reale cambio nei modelli di welfare e nel mercato occupazionale italiano. La cura dei figli ricade ancora prevalentemente sulle madri, e la persistente asimmetria nella divisione dei carichi domestici, insieme alla carenza di servizi, alimenta una cultura che funge più da ostacolo che da leva per la natalità.
Le conseguenze della crisi demografica si riflettono in modo diretto e severo sul mercato del lavoro e sulla struttura economica del Paese. A fronte di circa 6,1 milioni di occupati tra 50 e 59 anni che nei prossimi 10 anni si affacceranno alla pensione, la popolazione tra i 20 e i 29 anni di età, pari a circa 6 milioni di persone, è insufficiente per la sua completa sostituzione.
Mobilità e immigrazione
La crisi demografica italiana si intreccia con un’intensa mobilità, sia internazionale sia interna. Negli ultimi dieci anni, mezzo milione di giovani tra 18 e 34 anni ha lasciato l’Italia alla ricerca di migliori opportunità lavorative. Le cause sono molteplici: mercato del lavoro rigido, scarsi incentivi per i talenti, salari poco competitivi, diffusa mancanza di inclusione e scarsa meritocrazia.
I dati e le proiezioni indicano chiaramente che, nel medio termine, l'immigrazione è un "tampone" indispensabile per compensare il deficit demografico e la contrazione della forza lavoro, pur senza costituire la soluzione unica al problema.
Longevità e invecchiamento
Il progresso dell'aspettativa di vita rappresenta la seconda componente della problematica demografica italiana. L'aumento della longevità, pur essendo un positivo traguardo sociale, combinato con il calo delle nascite, sta portando a un rapido invecchiamento della popolazione. Nel 2024, la speranza di vita alla nascita si è attestata a 83,4 anni. L'età media della popolazione italiana, già la più alta d’Europa, è salita a 48,7 anni nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 50,6 anni nel 2050.
Le conseguenze di questo invecchiamento si riflettono sulla struttura dei consumi. L'incremento della popolazione anziana porterà a un aumento della spesa per salute, assistenza e servizi alla persona, a scapito di altre categorie di consumo come abbigliamento, trasporti e cultura. Questo cambiamento dei consumi influenzerà diversi settori economici, richiedendo una profonda riorganizzazione del tessuto produttivo e commerciale del Paese.
Sistema pensionistico
L’incremento della popolazione anziana e il calo di quella in età lavorativa rappresentano pertanto la prima e più critica fonte di fragilità strutturale del sistema pensionistico. Questo squilibrio intergenerazionale, aggravato da un mercato del lavoro giovanile caratterizzato da precarietà e bassi salari, alimenta un profondo senso di ingiustizia tra le nuove generazioni, le quali dovranno lavorare più a lungo per ottenere pensioni meno generose rispetto a quelle percepite da quelle precedenti.
Attualmente, si contano circa 72 pensionati ogni 100 lavoratori, e l'indice di dipendenza degli anziani (rapporto tra popolazione over-65 e popolazione attiva 15-64) è il più alto dell'Unione Europea, pari al 37,5% contro una media UE del 33%. Avere meno lavoratori (e meno giovani) significa peggiorare le performance del sistema economico.
Evoluzione e riforme del sistema pensionistico
L’Italia ha avviato una lunga stagione di riforme strutturali dal 1992 in poi. I “pilastri” delle riforme Amato, Dini e Fornero hanno progressivamente innalzato l’età pensionabile, imposto la rivalutazione dell’importo pensionistico su basi contributive, introdotto finestre di uscita flessibili, sviluppato la previdenza complementare. Queste riforme hanno avuto l’effetto di: ridurre gli spazi del pensionamento anticipato, aumentare l’età di uscita (oggi fissata a 67 anni, con possibilità di revisione in base all’aspettativa di vita futura), portare la gran parte dei lavoratori al calcolo totalmente contributivo dell’assegno pensionistico, con tassi di sostituzione (rapporto tra prima pensione e ultimo stipendio) in calo dal precedente 80% al 60%. La tendenza anche per il futuro sarà un innalzamento progressivo dell’età effettiva di pensionamento, l’esigenza di promuovere la previdenza complementare e il rafforzamento del legame tra contribuzione reale e importo dell’assegno pensionistico. Questo processo, accentuato dalle riforme che hanno ritardato l'età di uscita dal mercato del lavoro, solleva questioni sulla produttività e la capacità di adattamento dell'economia. Secondo l’OCSE le riforme delle pensioni devono essere accompagnate da sforzi per garantire che i lavoratori rimangano occupabili per tutta la vita, anche nelle ultime fasi della loro carriera.
Prospettive della previdenza complementare e riforme di lungo termine
L’adesione alle forme di previdenza complementare, nonostante un trattamento fiscale di favore, non ha ancora raggiunto i livelli degli altri Paesi. Nella classifica OCSE per patrimonio dei fondi pensione rispetto al PIL, l’Italia si posiziona al 25esimo posto. Per aumentare la sostenibilità del sistema pensionistico e garantire l’adeguatezza delle prestazioni, il Governo e le parti sociali intendono promuovere la previdenza complementare tuttora poco sviluppata rispetto al resto dell’UE (36% di adesione contro l’84% della Germania o l’88% del Regno Unito). Gli interventi prospettati prevedono il versamento automatico ai Fondi pensione del TFR in quanto determinante per assicurare un consistente afflusso di contributi al sistema della previdenza complementare. Nell’ottica di favorire la partecipazione alla previdenza complementare meritano di essere considerate anche alcune nuove proposte: ridefinizione dei limiti di deducibilità, fiscalità in fase di contribuzione, modalità di erogazione della prestazione finale, incentivi e semplificazione dell’offerta dei Fondi, maggiore educazione finanziaria dei lavoratori.
Effetti sul welfare sociale, povertà e coesione territoriale
L’inverno demografico aggrava la pressione su tutti gli ambiti del welfare: calano le risorse da redistribuire, aumenta la platea dei beneficiari (pensionati, anziani non autosufficienti, minori in famiglie vulnerabili), si allarga il divario tra territori e famiglie più o meno esposte al rischio di povertà. La spesa pubblica per prestazioni sociali ha raggiunto i 587 miliardi di euro nel 2025, per circa il 90% destinata a previdenza e assistenza, mentre appena il 10% finanzia misure dirette di inclusione sociale e servizi.
Affrontare la crisi demografica e le sue conseguenze sui sistemi di welfare richiede un approccio integrato, che agisca su più fronti in modo sinergico. Le soluzioni non risiedono in una singola politica, ma in un piano strategico basato su tre pilastri interconnessi: politiche a favore della natalità, gestione intelligente della migrazione e piena valorizzazione del potenziale lavorativo interno.
Considerazioni finali
Occorre agire sull’aumento del tasso di partecipazione attiva al lavoro, specialmente delle donne e dei giovani NEET, sulla prevenzione sanitaria e sulla formazione continua per aumentare produttività e capitale umano. Vanno superati gli interventi frammentari: è indispensabile una strategia integrata di medio-lungo termine con strumenti di welfare adattivi, investimenti mirati in servizi pubblici, un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico, una previdenza su più pilastri e una politica migratoria trasparente e proattiva. Solo così, l’Italia potrà tradurre la sfida dell’inverno demografico in una opportunità per costruire una società più coesa, produttiva e sostenibile.
01 novembre 2025
 Localizza
Localizza 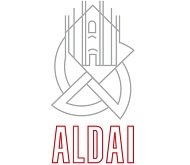




 Stampa
Stampa
 WhatsApp
WhatsApp







